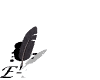TEMATICHE:
Due passi nell'Italia nascosta
Simbologia e Cultura Orientale
UTILITY:
Ricerca veloce titoli per argomento
SERVIZI:
Costituiscono un aspetto dell'architettura funeraria Etrusca i grandi tumuli della necropoli di Cerveteri, presso Roma.Si tratta di sepolcri monumentali contenenti anche tre o quattro tombe per varie generazioni di una stessa famiglia.Sono formate da un grande tumulo di terra innalzato sopra un'alta base circolare intagliata nel tufo, il cui diametro-in certi casi- può misurare 70 metri!
-
 'Melone'ritrovato nei
pressi di Cortona(Arezzo)-Tombe a tumulo
circolare,di epoca compresa tra il VI e il V secolo a.C.(etrusche).Per
ulteriori info http://www.cortonaguide.com/melone_ii.html
'Melone'ritrovato nei
pressi di Cortona(Arezzo)-Tombe a tumulo
circolare,di epoca compresa tra il VI e il V secolo a.C.(etrusche).Per
ulteriori info http://www.cortonaguide.com/melone_ii.html
- Architettura circolare funeraria romana
- In Età Augustea, 'modello' più
rappresentativo di tomba circolare è il Mausoleo dell'Imperatore
Augusto(Roma),
 che fu costruito
attorno al 28
a.C (secondo
alcuni autori nel 27 secondo altri nel 29 a.C.)tra la via Flaminia(oggi via
del Corso) e il Tevere,secondo
i dettami della più pura tradizione etrusco-italica,cioè a forma di tumulo su
basamento cilindrico.Il Mausoleo fu concepito molto probabilmente nell'ambito
di un progetto d'assetto dell'area più ampio, comprendente anche l'Horologium
solare, l'Ara Pacis Augustae e l'Ustrinum (il recinto sacro per la
cremazione dei defunti). Occupandoci della Basilica
di San Lorenzo in Lucina abbiamo visto come, a livello oggi sotterraneo,
potesse esservi un collegamento con dette strutture?
che fu costruito
attorno al 28
a.C (secondo
alcuni autori nel 27 secondo altri nel 29 a.C.)tra la via Flaminia(oggi via
del Corso) e il Tevere,secondo
i dettami della più pura tradizione etrusco-italica,cioè a forma di tumulo su
basamento cilindrico.Il Mausoleo fu concepito molto probabilmente nell'ambito
di un progetto d'assetto dell'area più ampio, comprendente anche l'Horologium
solare, l'Ara Pacis Augustae e l'Ustrinum (il recinto sacro per la
cremazione dei defunti). Occupandoci della Basilica
di San Lorenzo in Lucina abbiamo visto come, a livello oggi sotterraneo,
potesse esservi un collegamento con dette strutture?
Si vocifera che l'imperatore avesse visto il mausoleo di Alessandro Magno in Egitto,e pertanto ne volesse emulare la struttura per il proprio.
In origine, aveva un rivestimento di travertino (per un'altezza di 12 metri) e all'ingresso aveva due obelischi, che ora sono, rispettivamente, in Piazza dell'Esquilino e in piazza del Quirinale (adorna la fontana dei 'Dioscuri'). Prima dell'ingresso, su tavole in bronzo,si trovavano le Res Gestae Divi Augustae,che costituivano una sorta di 'riassunto'di 'autobiografia' dell'imperatore o princeps.
 .La
pianta circolare ha un diametro di 87 metri e si compone di ben cinque anelli
concentrici in tufo, in cui si aprono delle cappelle radiali che costituiscono
le tombe per i componenti della famiglia augustea ivi sepolti, a partire
da Marcello, il nipote e genero dell'imperatore(di questo si è certi per
via di una iscirizine superstite che si è conservato in situ);seguirono Agrippa,
Ottavia, Druso, Augusto nel 14 d.C.(e dopo molti anni sua moglie Livia);
Caligola, Claudio, Britannico, Vespasiano e Nerva. Nerone ne fu escluso forse
per una sorta di 'damnatio memoriae'. Non vi venne sepolta la figlia-ribelle di
Augusto, Giulia.La cella sepolcrale dell'Imperatore si
trovava proprio al centro del complesso, in una stanza quadrata. Direttamente
sopra di essa,all'esterno,era posizionata la statua in bronzo di Augusto,che
segnalava da lontano la presenza del Mausoleo.
.La
pianta circolare ha un diametro di 87 metri e si compone di ben cinque anelli
concentrici in tufo, in cui si aprono delle cappelle radiali che costituiscono
le tombe per i componenti della famiglia augustea ivi sepolti, a partire
da Marcello, il nipote e genero dell'imperatore(di questo si è certi per
via di una iscirizine superstite che si è conservato in situ);seguirono Agrippa,
Ottavia, Druso, Augusto nel 14 d.C.(e dopo molti anni sua moglie Livia);
Caligola, Claudio, Britannico, Vespasiano e Nerva. Nerone ne fu escluso forse
per una sorta di 'damnatio memoriae'. Non vi venne sepolta la figlia-ribelle di
Augusto, Giulia.La cella sepolcrale dell'Imperatore si
trovava proprio al centro del complesso, in una stanza quadrata. Direttamente
sopra di essa,all'esterno,era posizionata la statua in bronzo di Augusto,che
segnalava da lontano la presenza del Mausoleo.
 Pianta
dell'edificio,da
Pianta
dell'edificio,da
http://www.zetema.it/attachments/116/mausoleoaugusto4.gif
Il Mausoleo subì molte ingiurie da parte del tempo e degli uomini,e nel Medioevo divenne la fortezza della famiglia romana dei Colonna.Agli inizi del Novecento fu anche adibito a Sala per Concerti, denominata Auditorium Augusteo. Solo nel 1939 venne liberato dalle costruzioni che gli erano sorte addossate e ancor oggi si discute di ipotesi di ricostruzione. E'visitabile solo su prenotazione, per singoli e/ gruppi.
- Altri mausolei di questo tipo si trovano lungo la Via Appia in Roma :
- -quello detto
di Cotta al Sesto Miglio (attribuito a Marco Valerio Messalla
Corvino(detto in seguito Casal Rotondo perchè vi era sorto un
casale sulla sua sommità, che fu in seguito trasformato in villa)
 Eretto
intorno all'epoca di Augusto,è costituito da un corpo cilindrico,che un
tempo era rivestito di travertino, che si erge su un impianto quadrangolare
avente 35 m di lato31
d.C.e fatta
erigere dal figlio Messalino Cotta, un avvocato e letterato, mentre studi
più approfonditi sembrano attribuire il mausoleo a un membro della famiglia
degli Aurelii-Cotta.
Eretto
intorno all'epoca di Augusto,è costituito da un corpo cilindrico,che un
tempo era rivestito di travertino, che si erge su un impianto quadrangolare
avente 35 m di lato31
d.C.e fatta
erigere dal figlio Messalino Cotta, un avvocato e letterato, mentre studi
più approfonditi sembrano attribuire il mausoleo a un membro della famiglia
degli Aurelii-Cotta. - -quello di Cecilia Metella -
 ,ricordata in un'iscrizione sul tamburo,la quale doveva essere un
personaggio di spicco nella Roma del 50
a..C.,epoca in
cui venne eretto questo imponente Mausoleo. La sua tomba si trovava al primo
dei due piani di cui è costituito l'edificio; una cella circolare stretta e
sviluppata in altezza,un tempo coperta da una volta conica, le cui pareti
furono adeguatamente rivestite e coibentate per evitare l'infiltrazione di
umidità. L'ingresso originale della camera funeraria non è ancora stato
ritrovato;vi si accede per un ingresso realizzato nel Novecento dal
Munoz..L'edificio è però dotato anche di un percorso, analogo al 'dromos'
etrusco, tramite cui si può vedere la cella sepolcrale. Il piano superiore
è oggi inaccessibile al pubblico. La proprietaria della tomba era figlia di
Quinto Metello, console romano, e andò in sposa al figlio di quel Licinio
Crasso che aveva formato il triumvirato con Cesare e Pompeo(il
marito di Cecilia era Marco Crasso).Il Mausoleo ha un corpo
cilindrico alto 11 metri e del diametro di 30, rivestito di
travertino, eretto su una base rettangolare alta 8 metri. L'esterno
presenta decorazioni in rilievo, raffiguranti trofei di guerra e teste di
bovini,tanto da fare appellare il luogo 'Capo di Bove'.La zona in lieve
pendenza faceva sì che questo fosse un punto privilegiato,che dominava un
po' la via Appia. Il complesso fu adoperato in epoca Medievale e contornato
da una merlatura; in origine aveva invece un tumulo di terra a forma di cono
rovesciato, che si ergeva sulla sommità del tamburo cilindrico, e
probabilmente contornato da cipressi, come il Mausoleo di Augusto
caratteristica dell'architettura di tipo etrusco-italico delle tombe a
inumazione.
,ricordata in un'iscrizione sul tamburo,la quale doveva essere un
personaggio di spicco nella Roma del 50
a..C.,epoca in
cui venne eretto questo imponente Mausoleo. La sua tomba si trovava al primo
dei due piani di cui è costituito l'edificio; una cella circolare stretta e
sviluppata in altezza,un tempo coperta da una volta conica, le cui pareti
furono adeguatamente rivestite e coibentate per evitare l'infiltrazione di
umidità. L'ingresso originale della camera funeraria non è ancora stato
ritrovato;vi si accede per un ingresso realizzato nel Novecento dal
Munoz..L'edificio è però dotato anche di un percorso, analogo al 'dromos'
etrusco, tramite cui si può vedere la cella sepolcrale. Il piano superiore
è oggi inaccessibile al pubblico. La proprietaria della tomba era figlia di
Quinto Metello, console romano, e andò in sposa al figlio di quel Licinio
Crasso che aveva formato il triumvirato con Cesare e Pompeo(il
marito di Cecilia era Marco Crasso).Il Mausoleo ha un corpo
cilindrico alto 11 metri e del diametro di 30, rivestito di
travertino, eretto su una base rettangolare alta 8 metri. L'esterno
presenta decorazioni in rilievo, raffiguranti trofei di guerra e teste di
bovini,tanto da fare appellare il luogo 'Capo di Bove'.La zona in lieve
pendenza faceva sì che questo fosse un punto privilegiato,che dominava un
po' la via Appia. Il complesso fu adoperato in epoca Medievale e contornato
da una merlatura; in origine aveva invece un tumulo di terra a forma di cono
rovesciato, che si ergeva sulla sommità del tamburo cilindrico, e
probabilmente contornato da cipressi, come il Mausoleo di Augusto
caratteristica dell'architettura di tipo etrusco-italico delle tombe a
inumazione. - A Gaeta,sulla cima del Monte Orlando, ben conservato è il Mausoleo di Lucio Munazio Planco
 ,di forma
cilindrica,costruito nel 22 a.C., ha un'altezza di 13 metri e una circonferenza
di 92.50 metri.Poggiante
su due fasce di blocchi squadrati,il tamburo cilindrico è costituito da 12
strati di blocchi calcarei e reca una decorazione a rilievo raffigurante
trofei,scudi,armi,corone,triglifi e meteope. L'ingresso è orientato verso la
baia di Gaeta ed è sormontato da un'epigrafe dedicatoria entro una cornice di
forma rettangolare( immagine da http://strisceblu.altervista.org/munazio_planco.htm)
L'ingresso conduce ad un corridoio circolare al quale si accede tramite una
scala non coeva all'edificio ma costruita in seguito e che si apre su quattro
camere funerarie che formano una croce.La camera del titolare è orientata verso
l'ingresso dell'edificio(per
approfondimenti )
,di forma
cilindrica,costruito nel 22 a.C., ha un'altezza di 13 metri e una circonferenza
di 92.50 metri.Poggiante
su due fasce di blocchi squadrati,il tamburo cilindrico è costituito da 12
strati di blocchi calcarei e reca una decorazione a rilievo raffigurante
trofei,scudi,armi,corone,triglifi e meteope. L'ingresso è orientato verso la
baia di Gaeta ed è sormontato da un'epigrafe dedicatoria entro una cornice di
forma rettangolare( immagine da http://strisceblu.altervista.org/munazio_planco.htm)
L'ingresso conduce ad un corridoio circolare al quale si accede tramite una
scala non coeva all'edificio ma costruita in seguito e che si apre su quattro
camere funerarie che formano una croce.La camera del titolare è orientata verso
l'ingresso dell'edificio(per
approfondimenti )
-
 Il Tempio di Giove
Statore -situato nell'area dei Fori Imperiali a
Roma, fu per molto tempo considerato un edificio dedicato a Romolo, il
figlio dell'imperatore Massenzio morto giovanissimo nel 309 d.C..La
costruzione, preceduta da una facciata emiciclica, ha un corpo centrale
rotondo coperto a cupola e ha due corpi laterali di forma rettangolare ai
lati.
Il Tempio di Giove
Statore -situato nell'area dei Fori Imperiali a
Roma, fu per molto tempo considerato un edificio dedicato a Romolo, il
figlio dell'imperatore Massenzio morto giovanissimo nel 309 d.C..La
costruzione, preceduta da una facciata emiciclica, ha un corpo centrale
rotondo coperto a cupola e ha due corpi laterali di forma rettangolare ai
lati.
- Il Mausoleo di
Santa Costanza a Roma

(http://www.santagnese.org/foto/vista_aerea.jpg)
Fa parte del Complesso Monumentale di S. Agnese fuori le mura comprende le catacombe del II sec.d.C., la basilica del IV sec., quasi interamente scomparsa, mausoleo, basilica ricostruita sopra le catacombe nel VII secolo quando la prima venne abbandonata) . L'edificio è uno dei primissimi esempi paleocristiani che fondono architettura 'pagana'dei templi e dei ninfei. A lungo fu considerato un tempio dedicato a Bacco,per le numerose scene di vendemmia e a motivi vegetali, frutta, fiori, animali, uccelli, che ricoprono la volta musiva.Fu voluto dalla figlia dell'imperatore Costantino,Costanza e per il di lei marito, Annibaliano,erigendolo sul luogo delle catacombe dove si riteneva fosse sepolto il corpo della vergine e martire Agnese,morta nel circo di Domiziano.Di seguito,una particolareggiata analisi del complesso,con la descrizione, tratta da:http://www.santagnese.org/mausoleo.htm (NOTA 1)
Il mausoleo di S. Costanza
è uno dei caposaldi dell'architettura tardoantica. Fra i primi esempi
conservati (insieme al Battistero Lateranense) di edificio
cristiano a pianta centrale con ambulacro. Derivato da modelli romani di
templi e mausolei, ninfei, (il Pantheon, il Mausoleo di Augusto, il cosiddetto
tempio di Minerva Medica) deve la caratteristica più innovativa - i due spazi
circolari concentrici - a un edificio di poco precedente destinato ad
influenzare l'architettura medioevale: il Martyrium
del Santo Sepolcro eretto a Gerusalemme da Costantino e dalla madre Elena.
Pur essendo in parte
privato del suo primitivo splendore, conserva tuttora un'imponenza ed un fascino
straordinari, che peraltro ne fanno uno dei luoghi preferiti dalle coppie romane
per i matrimoni religiosi.
 Fu
eretto agli inizi del IV secolo da Costantina (o
Costanza), figlia di Costantino, a ridosso della grande
basilica
cimiteriale da lei fatta realizzare presso il cimitero sotterraneo ove
era sepolta la martire Agnese, di cui Costantina
stessa era una devota, anche a causa di una guarigione attribuita alla santa.
Fu
eretto agli inizi del IV secolo da Costantina (o
Costanza), figlia di Costantino, a ridosso della grande
basilica
cimiteriale da lei fatta realizzare presso il cimitero sotterraneo ove
era sepolta la martire Agnese, di cui Costantina
stessa era una devota, anche a causa di una guarigione attribuita alla santa.
Un esempio
simile - di integrazione tra mausoleo e basilica in epoca costantiniana -
è costituito dal mausoleo di Elena (madre di Costantino) - l'attuale Tor
Pignattara - realizzato a ridosso della basilica costantiniana dei SS.
Marcellino e Pietro sulla via Labicana, oggi via Casilina.
 L'edificio
era strettamente integrato con la basilica. Il nartece (1)
che ne costituisce l'ingresso, absidato ai lati, si innestava sulla navata
laterale della basilica e pertanto il mausoleo veniva a trovarsi trasversalmente
in asse con la basilica stessa.
L'edificio
era strettamente integrato con la basilica. Il nartece (1)
che ne costituisce l'ingresso, absidato ai lati, si innestava sulla navata
laterale della basilica e pertanto il mausoleo veniva a trovarsi trasversalmente
in asse con la basilica stessa.
L'interno
è costituito da una rotonda circolare (2) coperta a cupola, circondata da un
deambulatorio (3), e da esso separata da 12 coppie di colonne
di granito, tutte di spoglio, cioè ricavate da un
precedente edificio di epoca romana. I capitelli delle colonne sono legati fra
loro due a due da tronchi di architrave (pulvini)
disposti in senso radiale, così da creare moti centrifughi e centripeti che
accompagnano dalla penombra dell'ambulacro al luminoso spazio centrale.
La cupola
dell'ambiente centrale - avente 22,50 m di diametro - venne realizzata con una
tecnica costruttiva tipicamente romana, composta di nervature meridiane e solidi
archi in mattoni, che ingabbiano la concrezione di tufo e pietra pomice.
All'interno la cupola era
ricoperta di mosaici, oggi scomparsi, e le pareti sottostanti erano dotate di un
sontuoso rivestimento marmoreo in opus sectile (cioè
a tarsia), di cui oggi non ci rimangono che alcuni disegni, come testimonianze.
 A
fianco, l'interno di S. Costanza nel 1538-39 (Francisco de Hollanda, Escorial)
A
fianco, l'interno di S. Costanza nel 1538-39 (Francisco de Hollanda, Escorial)
Fu Urbano
VIII (1623-1644) ad elimiare i rivestimenti, a causa di una minaccia di crollo.
Rimangono comunque i 12 finestroni centinati che illuminano l'edificio nella sua
parte centrale, conferendogli quel dinamismo da cui deriva in buona parte del
fascino dell'edificio.
 L'ambulacro
è coperto con una volta a botte, decorata da magnifici mosaici del IV secolo,
che alternano motivi geometrici, scene di vendemmia, ritratti inseriti in
clipei, fra cui si potrebbero riconoscere, rispettivamente a sinistra e a destra
della nicchia frontale, Costantina e il primo marito Annibaliano, re del Ponto.
Tipico caso di adattamento di temi pagani alla tradizione cristiana, hanno fatto
sì che il mausoleo venisse a lungo identificato con il tempio
di Bacco. Il ritmo delle pareti laterali è scandito da numerose nicchie.
L'ambulacro
è coperto con una volta a botte, decorata da magnifici mosaici del IV secolo,
che alternano motivi geometrici, scene di vendemmia, ritratti inseriti in
clipei, fra cui si potrebbero riconoscere, rispettivamente a sinistra e a destra
della nicchia frontale, Costantina e il primo marito Annibaliano, re del Ponto.
Tipico caso di adattamento di temi pagani alla tradizione cristiana, hanno fatto
sì che il mausoleo venisse a lungo identificato con il tempio
di Bacco. Il ritmo delle pareti laterali è scandito da numerose nicchie.
 Le
quattro nicchie in corrispondenza dei quattro assi
sono di dimensioni maggiori: di forma rettangolare le due sull'asse
longitudinale, semicircolari quelle sull'asse trasversali. I corrispondenti
spazi tra le doppie colonne (intercolumni) sono più
larghi e più alti degli altri: in questo modo viene a crearsi uno schema
tipologico a croce inscritto in una circonferenza. La nicchia rettangolare
opposta all'entrata (4) ospitava il sarcofago di Costantina in porfido rosso (il
marmo riservato alla famiglia imperiale) decorato con motivi cristiani che
riprendono i temi della decorazione musiva dell'ambulacro. Il sarcofago è
conservato dalla fine del '700 nei Musei Vaticani; al suo posto è collocata una
copia in gesso.
Le
quattro nicchie in corrispondenza dei quattro assi
sono di dimensioni maggiori: di forma rettangolare le due sull'asse
longitudinale, semicircolari quelle sull'asse trasversali. I corrispondenti
spazi tra le doppie colonne (intercolumni) sono più
larghi e più alti degli altri: in questo modo viene a crearsi uno schema
tipologico a croce inscritto in una circonferenza. La nicchia rettangolare
opposta all'entrata (4) ospitava il sarcofago di Costantina in porfido rosso (il
marmo riservato alla famiglia imperiale) decorato con motivi cristiani che
riprendono i temi della decorazione musiva dell'ambulacro. Il sarcofago è
conservato dalla fine del '700 nei Musei Vaticani; al suo posto è collocata una
copia in gesso.
 Nelle
due nicchie maggiori poste al centro delle curve laterali, due scene a mosaico
della fine del IV secolo testimoniano il primato della chiesa di Roma sulla
cristianità: la Consegna delle chiavi e la Consegna del rotolo della Legge a
S.Pietro.
Nelle
due nicchie maggiori poste al centro delle curve laterali, due scene a mosaico
della fine del IV secolo testimoniano il primato della chiesa di Roma sulla
cristianità: la Consegna delle chiavi e la Consegna del rotolo della Legge a
S.Pietro.
 All'esterno
dell'ambulacro correva un'altro ambulacro colonnato, oggi scomparso. Nel
complesso quindi questo edificio, assieme alla basilica cui era annesso, riflette
le caratteristiche salienti dell'architettura costantiniana: grandiosità,
semplicità della pianta e dell'esterno, sfarzosità all'interno. (Krautheimer)
All'esterno
dell'ambulacro correva un'altro ambulacro colonnato, oggi scomparso. Nel
complesso quindi questo edificio, assieme alla basilica cui era annesso, riflette
le caratteristiche salienti dell'architettura costantiniana: grandiosità,
semplicità della pianta e dell'esterno, sfarzosità all'interno. (Krautheimer)
L'edificio nei secoli
La costruzione del
mausoleo, secondo studi recenti, sarebbe avvenuta in due fasi: una tra tra il
337 ed il 351 d.C. - nel periodo di vedovanza di Costantina - e l'altra dopo la
sua morte, ma comunque entro il 361. Successivamente fu sepolta nel mausoleo
anche Elena, altra figlia di Costantino.
Il mausoleo divenne in
seguito battistero della basilica di S. Agnese, sorta
nel VII secolo. La tipologia a pianta centrale si adattava in modo particolare a
tale destinazione d'uso, come ormai a quel tempo voleva la tradizione, anche se
non tutti gli studiosi sono concordi con questa destinazione d'uso.
Nel 1254 l'edificio fu
trasformato in chiesa, intitolata a S. Costanza. Ma
è sin dall'alto medioevo che Costanza (altro nome attribuito a Costantina
figlia di Constantino) veniva arbitrariamente identificata come una martire, e
quindi appellata come santa. Del resto già nell'835 il Liber pontificalis
designava per il mausoleo come Aecclesia Sanctae
Costantiae. Tale ambiguità è un tratto caratteristico dell'edificio,
che nelle sue forme architettoniche si rifà prevalentemente a modelli pagani di
templi e sepolcri.
Nel 1620 il cardinale
Fabrizio Veralli fece eliminare definitivamente la decorazione
musiva della cupola (splendida, secondo le testimonianze iconografiche
che ci sono giunte), già da tempo in pessimo stato di conservazione,
sostituendola con modesti affreschi.
 La
credenza - tipicamente umanista - secondo la quale l'edificio doveva essere un
tempio dedicato a Bacco, fece sì che esso divenne, nel XVII
secolo, un ritrovo di artisti fiamminghi, riuniti in un'associazione
chiamata Bentvogels (uccelli della banda). In
occasione dell'ammissione di un nuovo membro nell'associazione, si celebrava una
"festa del battesimo": dopo aver fatto bagordi per tutta la notte,
all'alba i bentvogels si recavano al cosiddetto
Sepolcro di Bacco (cioè il sepolcro di porfido che si trova all'interno del
mausoleo), per un'ultima libagione. Molti dei loro nomi sono rimasti amcora
incisi sugli affreschi delle nicchie.
La
credenza - tipicamente umanista - secondo la quale l'edificio doveva essere un
tempio dedicato a Bacco, fece sì che esso divenne, nel XVII
secolo, un ritrovo di artisti fiamminghi, riuniti in un'associazione
chiamata Bentvogels (uccelli della banda). In
occasione dell'ammissione di un nuovo membro nell'associazione, si celebrava una
"festa del battesimo": dopo aver fatto bagordi per tutta la notte,
all'alba i bentvogels si recavano al cosiddetto
Sepolcro di Bacco (cioè il sepolcro di porfido che si trova all'interno del
mausoleo), per un'ultima libagione. Molti dei loro nomi sono rimasti amcora
incisi sugli affreschi delle nicchie.
Nel 1720 Clemente XI proibì
quest'uso paganeggiante dell'edificio.
Un'ipotesi alternativa
Nel corso di una campagna
di scavi nella zona occidentale del nartece e
nell'esedra ovest del mausoleo (Stanley, 1992), sono state trovate numerose
tombe d'età tardoantica e medievale, tra cui due "sepolture
privilegiate". Inoltre sono stati rinvenuti resti di una struttura triconca,
che faceva parte che faceva parte dell'originario impianto della
basilica
cimiteriale, databile tra il 340 e il 350 d.C.
(per le strutture triconche, consulta
questa
pagina).
L'ipotesi formulata è che
l'edificio svolgesse la funzione di martyrium
per la venerazione di S. Agnese, e che di conseguenza Costanza
sarebbe stata sepolta altrove: per l'esattezza, in una
struttura
absidata al centro della basilica costantiniana.
Vedi anche:
Fusco.
La
tipologia a pianta centrale
L’elemento più peculiare
del mausoleo di S. Costanza è il suo svilupparsi secondo uno schema
a pianta centrale, cioè caratterizzato da una forma inscrivibile in un
quadrato, dove nessuna delle due dimensioni prevale sull’altra.
 Tale
schema è tipico dell’architettura cimiteriale,
nella quale la forma tonda può considerarsi diretta derivazione del tumulo,
ovvero del cumulo di terra che si elevava al di sopra della sepoltura. Né
possiamo escludere la persistenza di concetti simbolici tramandati dalle antiche
civiltà, in relazione ai culti del sole e del fuoco. Molti
esempi di mausolei a pianta circolare ci sono stati tramandati nella sola
città di Roma, tra i quali ricordiamo il mausoleo di Adriano (oggi Castel S.
Angelo) o la tomba di Cecilia Metella.
Tale
schema è tipico dell’architettura cimiteriale,
nella quale la forma tonda può considerarsi diretta derivazione del tumulo,
ovvero del cumulo di terra che si elevava al di sopra della sepoltura. Né
possiamo escludere la persistenza di concetti simbolici tramandati dalle antiche
civiltà, in relazione ai culti del sole e del fuoco. Molti
esempi di mausolei a pianta circolare ci sono stati tramandati nella sola
città di Roma, tra i quali ricordiamo il mausoleo di Adriano (oggi Castel S.
Angelo) o la tomba di Cecilia Metella.
 Inizialmente
realizzati secondo lo schema più semplice, senza divisioni interne e colla
copertura poggiante direttamente sui muri perimetrali, dal V secolo gli edifici
a pianta centrale vengono adottati anche per le funzioni di culto, con la
conseguente aggiunta di absidi, che ne determinano
anche un orientamento rispetto ad uno dei due assi.
Inizialmente
realizzati secondo lo schema più semplice, senza divisioni interne e colla
copertura poggiante direttamente sui muri perimetrali, dal V secolo gli edifici
a pianta centrale vengono adottati anche per le funzioni di culto, con la
conseguente aggiunta di absidi, che ne determinano
anche un orientamento rispetto ad uno dei due assi.
Ma lo schema più
frequente, tra gli edifici a pianta centrale, è quello che presenta un duplice
anello: uno interno che sostiene la copertura, l’altro esterno, a
costituire il deambulatorio mediano, a volte - come nel caso di S. Costanza -
circondato da un terzo anello. L’archetipo di questa tipologia è costituito
dalla rotonda dell’Anastasis o S. Sepolcro di Gerusalemme,
eretta da Costantino e formata da tre anelli concentrici, il minore dei quali,
al centro custodisce la cavità sacra. Molti edifici cristiani derivano da
questo modello. Un altro esempio, a Roma, è la chiesa di S. Stefano Rotondo,
del V secolo.

Molte varianti della pianta
centrale contemplano il ricorso alle absidi semicircolari,
che hanno la funzione di sostegno, contribuendo al contempo ad allargare lo
spazio interno. Le absidi sono prevalenti negli edifici polilobati, cioè basati
su una combinazione cruciforme a tre o quattro absidi, andanti a formare il triconco
(a 3 abisdi) - adottato di preferenza a mausolei, battisteri e piccoli martyria
-
 o
il tetraconco (4
absidi), o quadrifoglio.
Dal presbiterio a triconco si sviluppò gradualmente la basilica a transetto con
bracci terminanti in pareti curve. Il quadrifoglio era invece una forma più
completa e stabile dal punto di vista strutturale, ed ebbe fortuna specialmente
dopo il VI secolo, evolvendosi nello schema a croce
quadrifogliata, dove - a differenza del tetraconco
- il diametro di ciascun abside è minore del lato del quadrato centrale.
o
il tetraconco (4
absidi), o quadrifoglio.
Dal presbiterio a triconco si sviluppò gradualmente la basilica a transetto con
bracci terminanti in pareti curve. Il quadrifoglio era invece una forma più
completa e stabile dal punto di vista strutturale, ed ebbe fortuna specialmente
dopo il VI secolo, evolvendosi nello schema a croce
quadrifogliata, dove - a differenza del tetraconco
- il diametro di ciascun abside è minore del lato del quadrato centrale.
 Particolarmente
fertile fu il filone a pianta centrale sviluppato a Milano,
allorché divenne sede della corte imperiale. Esempio tipico di questa tendenza
è la chiesa di S. Lorenzo. La fioritura artistica di questo periodo nella città
lombarda è fortemente influenzata dall’oriente ellenistico, stabilendo quasi
un ponte di lancio dell’architettura bizantina, che porterà alla
realizzazione di capolavori a pianta centrale come S. Vitale, a Ravenna
- la città del coevo Mausoleo di Teodorico, a pianta circolare - e S. Sofia a Costantinopoli.
Particolarmente
fertile fu il filone a pianta centrale sviluppato a Milano,
allorché divenne sede della corte imperiale. Esempio tipico di questa tendenza
è la chiesa di S. Lorenzo. La fioritura artistica di questo periodo nella città
lombarda è fortemente influenzata dall’oriente ellenistico, stabilendo quasi
un ponte di lancio dell’architettura bizantina, che porterà alla
realizzazione di capolavori a pianta centrale come S. Vitale, a Ravenna
- la città del coevo Mausoleo di Teodorico, a pianta circolare - e S. Sofia a Costantinopoli.
Fonte
principale:
Testini,
1980.
NOTA 1: per l'utilizzazione del materiale sul Mausoleo di S.Costanza si è fatto riferimento all'informativa indicata nel sito medesimo http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/it/
Il singolare Tempio non ha ancora un preciso riferimento architettonico,in quanto presenterebbe caratteristiche tecniche sia dell'arte religiosa siriaca che dell'arte barbarica. Fu edificato dall'imperatore Teodorico nel VI sec.d.C. e si presenta di un colore bianco molto affascinante,in pietra squadrata e formato da due corpi sovrapposti: quello inferiore è un decagono con arcate cieche e all'interno c'è una cella funeraria cruciforme; quello superiore è rivestito da una cupola schiacciata e contiene una cella rotonda.