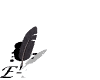TEMATICHE:
Due passi nell'Italia nascosta
Simbologia e Cultura Orientale
UTILITY:
Ricerca veloce titoli per argomento
SERVIZI:
Oschiri
Altare Rupestre
Carlo MF Capone
2010 c . c a p o n e @ r s a d v n e t . i t
Sito megalitico? Necropoli? Domus de janas? Osservatorio astronomico? Cenobio bizantino? A Oschiri (prov. di Olbia-Tempio, in Sardegna), nel sito conosciuto come Altare Rupestre, c'è tutto questo e forse altro ancora. C'è anche una chiesetta edificata nel 1492 e dedicata a S. Stefano, oggi un po' trascurata che si riapre nelle festività dedicate al Santo, ma che è li a indicare qualcosa.
 Gigi Sanna (1) ha decifrato l'epigrafe incisa su una lapide di tracheite sotto
il volto incastonato nella facciata laterale della chiesetta e che era stato
messo in relazione alla dea Astarte; si tratta molto più prosaicamente
dell'effigie di Donna Masala, una pia nobildonna dell'epoca alla quale si deve
la costruzione dell'edificio; ma se ci si ferma a guardare l'ingresso della
chiesetta, posto proprio di fronte all'altare rupestre, un altro volto molto
più enigmatico è posto sopra l'architrave del portone di ingresso: i tratti
consunti dal tempo e l'assenza di epigrafi, non consentono di individuare
qualcuno e lasciano questa faccina a guardia del sito; potrebbe essere una
figura apotropaica posta lì a proteggere la sacralità del luogo?
Gigi Sanna (1) ha decifrato l'epigrafe incisa su una lapide di tracheite sotto
il volto incastonato nella facciata laterale della chiesetta e che era stato
messo in relazione alla dea Astarte; si tratta molto più prosaicamente
dell'effigie di Donna Masala, una pia nobildonna dell'epoca alla quale si deve
la costruzione dell'edificio; ma se ci si ferma a guardare l'ingresso della
chiesetta, posto proprio di fronte all'altare rupestre, un altro volto molto
più enigmatico è posto sopra l'architrave del portone di ingresso: i tratti
consunti dal tempo e l'assenza di epigrafi, non consentono di individuare
qualcuno e lasciano questa faccina a guardia del sito; potrebbe essere una
figura apotropaica posta lì a proteggere la sacralità del luogo?
 Molte
ipotesi sono state avanzate per spiegare la particolarità del complesso
monumentale; perché tante pietre accuratamente lavorate, con differenti moduli
di lavorazione, con precisi orientamenti? Perché tante nicchie di forma diversa
isolate, raggruppate in lastroni granitici o unificate in un grandioso megalite?
Quest'ultimo è una roccia affiorante o è stato collocato intenzionalmente?
Deciso a capire qualcosa di più ho vissuto una giornata immerso in questo
luogo, una bellissima giornata, mite, con cieli tersi, silenzio e il regolare
procedere del sole che nel primo pomeriggio mi ha reso spettatore di un piccolo
ma significativo fenomeno. Ero partito con un'idea, venutami osservando le varie
immagini reperibili in internet, e che mi tornavano in mente come
un'ossessione: immaginavo attorno a quella pietra uomini che periodicamente
collocavano nelle nicchie segni di devozione, auguri, speranze e cercavano di
farlo unendosi al ritmo delle stagioni, dei mesi, dei giorni; alcuni cercavano
di annotare, ricordare e comunicare agli altri come questi eventi si
susseguissero nel tempo con una regolarità sufficiente a renderli
riconoscibili. Un posto in cui giorno dopo giorno la vita scorreva con
immutabile sicurezza. Ecco perché pensavo che quel luogo potesse essere al
tempo stesso un centro di espressione religiosa e uno strumento per fornire agli
uomini una misura del tempo. Ma le foto non erano sufficienti, dovevo viverlo
quel posto.
Molte
ipotesi sono state avanzate per spiegare la particolarità del complesso
monumentale; perché tante pietre accuratamente lavorate, con differenti moduli
di lavorazione, con precisi orientamenti? Perché tante nicchie di forma diversa
isolate, raggruppate in lastroni granitici o unificate in un grandioso megalite?
Quest'ultimo è una roccia affiorante o è stato collocato intenzionalmente?
Deciso a capire qualcosa di più ho vissuto una giornata immerso in questo
luogo, una bellissima giornata, mite, con cieli tersi, silenzio e il regolare
procedere del sole che nel primo pomeriggio mi ha reso spettatore di un piccolo
ma significativo fenomeno. Ero partito con un'idea, venutami osservando le varie
immagini reperibili in internet, e che mi tornavano in mente come
un'ossessione: immaginavo attorno a quella pietra uomini che periodicamente
collocavano nelle nicchie segni di devozione, auguri, speranze e cercavano di
farlo unendosi al ritmo delle stagioni, dei mesi, dei giorni; alcuni cercavano
di annotare, ricordare e comunicare agli altri come questi eventi si
susseguissero nel tempo con una regolarità sufficiente a renderli
riconoscibili. Un posto in cui giorno dopo giorno la vita scorreva con
immutabile sicurezza. Ecco perché pensavo che quel luogo potesse essere al
tempo stesso un centro di espressione religiosa e uno strumento per fornire agli
uomini una misura del tempo. Ma le foto non erano sufficienti, dovevo viverlo
quel posto.
 L'altare rupestre domina tutto il paesaggio: un lungo monolite inciso da nicchie
quadrate, sub-triangolari e circolari, 13 nicchie scolpite e allineate nel
registro inferiore, le ultime due a destra per chi guarda, separate dalle altre
da un elemento a gradini. Tutte rivolte ad est.
L'altare rupestre domina tutto il paesaggio: un lungo monolite inciso da nicchie
quadrate, sub-triangolari e circolari, 13 nicchie scolpite e allineate nel
registro inferiore, le ultime due a destra per chi guarda, separate dalle altre
da un elemento a gradini. Tutte rivolte ad est.
 La
seconda nicchia da sinistra, non è scavata ma incisa, unica in tutto il sito.
La
seconda nicchia da sinistra, non è scavata ma incisa, unica in tutto il sito.
 Altre
nicchie nel registro superiore, dove spicca un gruppo di tre a forma triangolare
contornate da coppelle, e più a destra una nicchia perfettamente circolare. Una
sughera cresce in stretto rapporto con l'altare. Spontanea?
Altre
nicchie nel registro superiore, dove spicca un gruppo di tre a forma triangolare
contornate da coppelle, e più a destra una nicchia perfettamente circolare. Una
sughera cresce in stretto rapporto con l'altare. Spontanea?
 A destra dell'altare, orientata a sud, una formazione di 12 coppelle che
contornano un elemento circolare più grande, ma la coppella scavata alle ore 12
di questa meridiana è sormontata da una 13a coppella, poco più in là un
simulacro di sepoltura, orientata a sud, rettangolare, poco profonda.
A destra dell'altare, orientata a sud, una formazione di 12 coppelle che
contornano un elemento circolare più grande, ma la coppella scavata alle ore 12
di questa meridiana è sormontata da una 13a coppella, poco più in là un
simulacro di sepoltura, orientata a sud, rettangolare, poco profonda.

 Dietro l'altare su una lunga roccia 13 coppelle scolpite in fila contornate da
altre disposte in modo meno regolare, e più in dietro un lastrone granitico che
porta incisi tre quadrati disposti in una formazione suggestiva: la cintura di
Orione.
Dietro l'altare su una lunga roccia 13 coppelle scolpite in fila contornate da
altre disposte in modo meno regolare, e più in dietro un lastrone granitico che
porta incisi tre quadrati disposti in una formazione suggestiva: la cintura di
Orione.
Alle spalle del sito, verso ovest, almeno cinque formazioni ipogee (non accessibili) sovrastate da rocce tafonate alcune delle quali adattate da mano umana a svolgere funzioni non solo decorative; in una di queste (identificata col n. 5 nella cartina del sito disposta all'ingresso) un inconfondibile "occhio solare".

 Perché il numero 13 ritorna con insistenza in questo luogo? E cosa potrebbe
indicare se si pensasse ad una possibile misurazione del tempo? In un anno
solare trascorrono 13 lunazioni, i giorni della luna crescente sono 13 come
quelli della luna calante, un antichissimo orologio lunare databile intorno al
13.000 a.C. ritrovato a Lascaux in Francia e conosciuto come il Cervo di Lascaux,
mostra 13 punti dipinti e allineati, preceduti da una figura quadrangolare che
è stata interpretata da André Leroi-Gourhan in un articolo apparso su Le
Scienze nel novembre 1968, come un simbolo femminile e che rimanda alla Venere
di Laussel (23.000 a.C) che regge un corno con incisi tredici segni verticali.
Perché il numero 13 ritorna con insistenza in questo luogo? E cosa potrebbe
indicare se si pensasse ad una possibile misurazione del tempo? In un anno
solare trascorrono 13 lunazioni, i giorni della luna crescente sono 13 come
quelli della luna calante, un antichissimo orologio lunare databile intorno al
13.000 a.C. ritrovato a Lascaux in Francia e conosciuto come il Cervo di Lascaux,
mostra 13 punti dipinti e allineati, preceduti da una figura quadrangolare che
è stata interpretata da André Leroi-Gourhan in un articolo apparso su Le
Scienze nel novembre 1968, come un simbolo femminile e che rimanda alla Venere
di Laussel (23.000 a.C) che regge un corno con incisi tredici segni verticali.

Franco Ruggieri (2) ha individuato a Cuma sulla parete occidentale del dromos conosciuto come Antro della Sibilla una serie di segni che compongono a suo giudizio tre tipi di calendari lunari, due di questi sono composti da 13 segni verticali. Alexander Marshak (3) ci ricorda che già nel Paleolitico Superiore esisteva un sistema di misurazione del tempo basato sull'osservazione delle fasi lunari: " il ciclo lunare era analizzato, memorizzato e utilizzato per scopi pratici circa 15.000 anni prima della scoperta dell'agricoltura. In base a ciò si può capire meglio la grande importanza della luna nelle mitologie arcaiche, e soprattutto l'integrazione in un unico sistema, da parte del simbolismo lunare, di realtà diverse tra loro come la donna, le acque, la vegetazione, il serpente, la fertilità, la morte, la rinascita". E ad Oschiri? E' proprio solo fantasia pensare che gli artefici di questo sito appartenessero ad antiche civilizzazioni che avevano imparato ad osservare il cielo notturno con il suo corredo di stelle fisse, costellazioni mobili intorno ad un punto fisso e alternanza regolare di notti illuminate e notti buie? E fissare in ogni segno (nicchie, coppelle, rappresentazioni celesti) un evento con le sue particolarità che lo rendeva riconoscibile periodicamente e quindi prevedibile, per collegare a questo le attività quotidiane e in qualche misura una speranza nella ciclicità dell'esistenza? Questa ipotesi non esclude il riutilizzo e le modificazioni che possano essersi succedute nelle epoche successive e che abbiano voluto iscrivere nel sito il segno dei propri tempi. In ogni caso questo è ciò che ho potuto leggere durante la mia giornata ad Oschiri, che visiterò ancora perché molte altre cose sono presenti lì e non tutte sono comprensibili in un'unica per quanto meravigliosa esperienza.
Minima bibliografica
| 1. Astarte? Macchè, solo Donna Masala. in http://gianfrancopintore.blogspot.com/search?q=astarte | |
| 2. Alexander Marshak - The Roots of Civilization, p. 81 e ss. in Mircea Eliade – Storia delle credenze e delle idee religiose, Vol. I, pag. 34, Firenze, 1979 | |
| 3. F. Ruggeri, Calendari lunari a Cuma: http://digilander.libero.it/FRRU/CaLuCu/CaLCu.htm |
(Autore: Carlo MF Capone, 2010)
Sezioni correlate in questo sito:
| Antiche civiltà |
www.duepassinelmistero.com Avvertenze/Disclaimer
Ottobre 2011