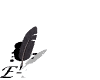TEMATICHE:
Due passi nell'Italia nascosta
Simbologia e Cultura Orientale
UTILITY:
Ricerca veloce titoli per argomento
SERVIZI:

(di Marisa Uberti)
Premessa: le donne, figlie di un dio minore?
La società contemporanea è abituata già da qualche anno, se non decennio, a vedere regolarmente figure femminili in qualità di ricercatrici e docenti, non solo la 'mitica' maestra delle elementari o la "prof" delle medie inferiori, ma anche agli istituti superiori e alle università.. E' stato, quest'ultimo, un traguardo, se pensiamo che alla fine del XIX secolo e anche all'inizio del XX, la cultura che era richiesta ad una donna non andava oltre la capacità di tenere una ...conversazione! Era ritenuto addirittura 'sconveniente' che una fanciulla di acculturasse o andasse 'al di là' di quello che era richiesto dal proprio ruolo nella vita (comunemente moglie e madre, almeno fino della rivoluzione industriale ottocentesca). Nelle società primordiali, però, è stato accertato che le donne partecipassero attivamente alle attività di caccia e agricoltura insieme agli uomini, e solo con l'introduzione di strumenti ausiliari che migliorarono il lavoro nei campi, alle donne fu progressivamente 'consentito' del tempo per dedicarsi ad altre attività (angeli del focolare, educatrici della prole, tessitrici, pastorelle, etc.). Non potremo mai sapere se furono donne a disegnare nelle grotte (perchè no?), a dipingerle, o a incidere le rocce rupestri, a realizzare le prime sculture lignee o ceramiche, ad avere delle intuizioni fondamentali come la scoperta del fuoco o della ruota, del telaio o della cottura dei materiali argillosi, la 'scoperta' dei metalli e altro ancora. Probabilmente a nessuno è mai sorta lontanamente la domanda e tutto sommato non farebbe differenza. Ma tutto dipende da quanta possibilità le donne hanno avuto di proporre le proprie idee all'interno di una comunità, del grado di cultura che una civiltà ha dimostrato di possedere, perchè quando questa è stata elevata (come quella dell'antico Egitto, ad esempio) le donne hanno goduto di notevole importanza nella vita quotidiana, hanno conquistato ruoli preminenti, paritari all'uomo, sono state rispettate e considerate.
Non sono mancate personalità femminili che si sono distinte nel corso della storia umana, sia chiaro, e non solo come 'mogli' o 'figlie' o parenti di re e imperatori, ma come protagoniste principali, alle prese con regni e imperi, strateghe, artiste, umaniste, ricercatrici, sante o muse ispiratrici, e non per questo meno importanti.
Se io citassi il nome di Flavia Julia Helena Augusta, e aggiungessi che nacque nel 250 d.C. circa in Bitinia, molte persone si interrogherebbero su chi fosse costei, ma se aggiungo che fu la madre dell'imperatore Costantino il grande, allora tutto cambierebbe, non è così? Eppure a lei è attribuita la prima grande scoperta archeologica per la cristianità: i frammenti della Vera Croce, la roccia del Golgota e il sepolcro di Gesù Cristo. Dici poco! Addirittura, in suo onore, la sua città natale venne chiamata Helenopolis, e non si sa se venne aiutata nelle sue imprese dall'avere sposato Flavio Costantino(o esserne stata l'amante), da cui ebbe appunto il futuro imperatore romano, nato nel 272 d.C. circa. Sappiamo che Elena morì attorno al 330 d.C., che influenzò la 'conversione' dell'impero al cristianesimo e che fu fatta santa.
Sorvolando sui millenni, sulla storia nota e meno nota del ruolo che -volenti o nolenti- le donne si sono viste affibiare (anche quello umiliante e arbitrario di 'streghe', quando volevano saperne di più in tempi proibiti), approdiamo nel fermento del 'secolo dei Lumi' (1700), in cui si assistette ad un recupero delle capacità umane in differenti campi scientifici, tra i quali l'archeologia o, per meglio dire a quei tempi, dello studio del passato. Possiamo soltanto immaginare le difficoltà che le donne incontrarono per farsi largo in una società piuttosto restìa ad aprirsi alle loro aspirazioni, che per natura dovrebbe essere assolutamente uguali a quelle maschili, e come tali assecondate e incentivate allo stesso modo. Utopia! L'essere donne in un campo di conoscenza e applicazione che era monopolizzato dai maschi, era penalizzante. Ma ancor peggio, ritenuto inutile e perfino sconveniente. Ma questo non ha impedito a molte di distinguersi e ricoprire, progressivamente, posti di rilievo nella storia. Ci occuperemo in questa sede delle pioniere dell'archeologia.
Come vedremo nell'illustrare le singole esistenze di queste valenti donne, non furono quasi mai di estrazione sociale bassa (studiare costa) e, se ci faremo caso, noteremo come l'aver avuto accanto personalità influenti sottoforma di professori universitari o mariti importanti, ebbe un certo peso. Tuttavia ciascuna, pur avendo una storia a sè, condivide con le altre l'aver saputo farsi largo con la sola dote dell' intelligenza e della bravura, la loro capacità, il loro impegno e la loro competenza altamente apprezzata a livello mondiale, facendosi ricordare per quello che fecero e produssero, anche se si è soliti aggiungere 'moglie di', 'allieva di', cosa che ad un uomo non accade quasi mai. Alcune di loro non si laurearono mai ma riuscirono ugualmente a dimostrare il loro valore in campo archeologico, umanistico e letterario, pubblicando testi fondamentali per la comunità scientifica. Non mancarono però casi amari, conclusisi tristemente, e sempre per l'ottusità umana.
L'opportunità fondamentale allo sviluppo dei un'archeologia al femminile venne fornita dalla creazione delle Scuole di Archeologia. Per l'Italia, nel 1909, venne fondata a Creta dal prof. Federico Halbherr, la Scuola Archeologica Italiana ad Atene, dove confluivano tutti gli aspiranti ricercatori di archeologica classica del tempo. Per il gentil sesso rappresentava, per quei tempi pionieristici che vanno dal 1910 al 1940 almeno- tre aspetti peculiari favorenti: - la sede fisica per l'apprendimento/ perfezionamento da cui derivava -una tranquillità (garanzia di protezione) sia per le archeologhe che per le loro famiglie a casa, e infine la possibilità di seguire gli scavi concordati o gestiti dalla scuola stessa. Delle innumerevoli iscritte, poche però scelsero di darsi alla ricerca 'sul campo', optando per la maggior parte per ruoli meno 'avventurosi' come la docenza in istituti scolastici. Altre associarono sia l'una che l'altra attività. Ma quando ancora non si parlava di Scuole di questo tipo, alcune avevano già la ricerca archeologica nel sangue...
Avviamoci dunque in questi due passi nell'affascinante mondo dell'archeologia pionieristica al femminile. Dove le italiane, tra l'altro, sono state particolarmente precoci e incisive.
Le 'pioniere' nate nel XVIII secolo: Marianna Candidi Dionigi e Sarah Belzoni
![]() Sarah
Belzoni. Era di origine inglese o forse irlandese, nata verso la fine del XVIII secolo; conobbe Giovan Battista Belzoni nel 1803, quando questi
andò per la prima volta in Inghilterra e lo seguì quando lui decise di andare
in Egitto, nel 1815. E' descritta come una donna affascinante e
intraprendente, sempre al seguito del marito sia nella sua precedente attività
circense sia nelle sue nuove vesti di esploratore egiziano. Insieme scoprirono
la tomba del faraone Sethi I ma rimase ad Assuan quando Giovanni
si diresse più a sud, per intraprendere la ripulitura del tempio di Abu-Simbel,
fino a quel momento invaso dalla sabbia e dimenticato nell'oblio. Sarah non
stette con le mani in mano e scrisse un capitolo di 42 pagine sulle donne
egiziane, della Nubia e della Siria, che incluse nel libro del marito "Narrative
of the operations and recent discoveries within the pyramidis...and of a
journey to the coast of the Red Sea", in cui si faceva un resoconto
delle operazioni e delle scoperte condotte da loro in Egitto. Sarah attraversò
da sola alcuni luoghi alla ricerca di tradizioni da conoscere, specialmente
relative alle condizioni femminili e riportò i suoi racconti della vita
domestica di Arabi e Turchi; viaggiò in Terra Santa e quando tornò in Egitto
distribuì copie della Bibbia nei pressi di Rosetta, nel delta del Nilo,
compiendo a suo modo l'evangelizzazione cristiana dei nativi, anche se con
scarsi risultati. Dopo la morte del marito, avvenuta nel 1823, Sarah
allestì una esposizione a Londra dei reperti che avevano fino a quel momento
ammucchiato. Ciò non le fruttò molta fortuna economica; il Parlamento inglese
le passò una pensione civile fino a tarda età.
Sarah
Belzoni. Era di origine inglese o forse irlandese, nata verso la fine del XVIII secolo; conobbe Giovan Battista Belzoni nel 1803, quando questi
andò per la prima volta in Inghilterra e lo seguì quando lui decise di andare
in Egitto, nel 1815. E' descritta come una donna affascinante e
intraprendente, sempre al seguito del marito sia nella sua precedente attività
circense sia nelle sue nuove vesti di esploratore egiziano. Insieme scoprirono
la tomba del faraone Sethi I ma rimase ad Assuan quando Giovanni
si diresse più a sud, per intraprendere la ripulitura del tempio di Abu-Simbel,
fino a quel momento invaso dalla sabbia e dimenticato nell'oblio. Sarah non
stette con le mani in mano e scrisse un capitolo di 42 pagine sulle donne
egiziane, della Nubia e della Siria, che incluse nel libro del marito "Narrative
of the operations and recent discoveries within the pyramidis...and of a
journey to the coast of the Red Sea", in cui si faceva un resoconto
delle operazioni e delle scoperte condotte da loro in Egitto. Sarah attraversò
da sola alcuni luoghi alla ricerca di tradizioni da conoscere, specialmente
relative alle condizioni femminili e riportò i suoi racconti della vita
domestica di Arabi e Turchi; viaggiò in Terra Santa e quando tornò in Egitto
distribuì copie della Bibbia nei pressi di Rosetta, nel delta del Nilo,
compiendo a suo modo l'evangelizzazione cristiana dei nativi, anche se con
scarsi risultati. Dopo la morte del marito, avvenuta nel 1823, Sarah
allestì una esposizione a Londra dei reperti che avevano fino a quel momento
ammucchiato. Ciò non le fruttò molta fortuna economica; il Parlamento inglese
le passò una pensione civile fino a tarda età.
Le 'pioniere' del XIX -XX° sec.: i primi grandi passi al femminile e... per la scienza!
![]() Hilda Petrie (1871-1956),
inglese. Questo cognome è noto ai cultori di egittologia: sir William
Matthew Flinders Petrie è infatti considerato il padre
dell'archeologia scientifica, fondatore in Egitto di una scuola di
archeologia. Il suo cognome da nubile non lo abbiamo trovato (!). Hilda,
avendo studiato geologia, fu notata da Petrie come studiosa, e in seguito si
sposarono. Partirono per l'Egitto nel 1896 e il primo sito in cui Hilda
lavorò fu Dendera, seguito da altri siti. Nel 1905 fu a
Saqquara con una spedizione composta esclusivamente da donne,
lavorando nelle tombe dell'Antico Regno faraonico. Immaginiamo come doveva
essere vista questa esperienza ai loro occhi, le implicazioni psicologiche, le
emozioni e la sfida che stavano lanciando al mondo! Donne in missione
archeologica! Doveva sembrare incredibile anche alle loro omologhe che,
quotidianamente, erano alle prese con figli, mariti, genitori da accudire.
Invece queste intrepide esploratrici stavano vivendo una fondamentale stagione
per l'archeologia scientifica mondiale. Anche Hilda fu madre, di due bambini.
Dopo una breve esperienza come docenti alla London College University,
i Petrie tornarono in Egitto e poi in Palestina, a Gerusalemme. Quando
nel 1942 Flinders morì, Hilda visse all'American School
pubblicando i lavori del marito per farli conoscere alla comunità scientifica;
nel 1952 tornò in Inghilterra e pubblicò le scoperte fatte nel 1905 con
la sua equipe tutta al femminile. Morì nel 1956, a 85 anni.
Hilda Petrie (1871-1956),
inglese. Questo cognome è noto ai cultori di egittologia: sir William
Matthew Flinders Petrie è infatti considerato il padre
dell'archeologia scientifica, fondatore in Egitto di una scuola di
archeologia. Il suo cognome da nubile non lo abbiamo trovato (!). Hilda,
avendo studiato geologia, fu notata da Petrie come studiosa, e in seguito si
sposarono. Partirono per l'Egitto nel 1896 e il primo sito in cui Hilda
lavorò fu Dendera, seguito da altri siti. Nel 1905 fu a
Saqquara con una spedizione composta esclusivamente da donne,
lavorando nelle tombe dell'Antico Regno faraonico. Immaginiamo come doveva
essere vista questa esperienza ai loro occhi, le implicazioni psicologiche, le
emozioni e la sfida che stavano lanciando al mondo! Donne in missione
archeologica! Doveva sembrare incredibile anche alle loro omologhe che,
quotidianamente, erano alle prese con figli, mariti, genitori da accudire.
Invece queste intrepide esploratrici stavano vivendo una fondamentale stagione
per l'archeologia scientifica mondiale. Anche Hilda fu madre, di due bambini.
Dopo una breve esperienza come docenti alla London College University,
i Petrie tornarono in Egitto e poi in Palestina, a Gerusalemme. Quando
nel 1942 Flinders morì, Hilda visse all'American School
pubblicando i lavori del marito per farli conoscere alla comunità scientifica;
nel 1952 tornò in Inghilterra e pubblicò le scoperte fatte nel 1905 con
la sua equipe tutta al femminile. Morì nel 1956, a 85 anni.
![]() Dorothy Annie Elizabeth
Garrod (1892-1969). Inglese. Si laureò a Oxford ed è considerata una vera
pioniera per la scienza archeologica e di primati ne ha conseguiti tanti. Fu
la prima donna - professore all'Università di Cambridge, nominata il 3
marzo del 1939. Fu la prima ad incorporare la fotografia aerea negli
scavi. E' stata la prima donna a ricevere la medaglia d'oro della
Società di antiquari di Londra. I suoi scavi la videro attiva in
Inghilterra, Palestina, Kurdistan, Bulgaria, Gibilterra e Libano. Spese
molte forze nelle ricerche del Vicino Oriente, in particolar modo ristette due
anni sul Monte Carmelo, dove fece importanti scoperte in campo
paleo-antropologico; fu una pioniera anche in questo.Nelle grotte del Carmelo
ritrovò molti scheletri di Neanderthal, insieme a strumenti vari e
comprese la fondamentale nozione- fino a quel momento ignorata- che il
Neanderthal fosse vissuto anche fuori dall'Europa, cosa che non si
riteneva possibile. Dorothy concluse, dopo attente ricerche, che i
Neanderthals in Europa e nel Vicino Oriente coesistevano, esistevano
cioè nella stessa epoca, anche se quelli in Europa erano più primitivi.
Questo, naturalmente, provocò qualche emozione e anche reazione negativa
perchè scardinava la teoria allora in vigore, circa il concetto di
evoluzione lineare. La Garrod fece fare grandi progressi alla scienza in
diversi campi tra cui l'arte paleolitica, le migrazioni dell'uomo preistorico
e i metodi di irrigazione che impiegava, le tecniche di caccia che usava;
inoltre, analizzando i resti della fauna in vari distretti, fu in grado di
definire chiaramente come anticamente le condizioni climatiche ed ecologiche
dovevano essere mutate. Insegnò all'Università di Cambridge fino al 1952.
Nel 1956 le donne entrarono a pieno titolo nell'Università come docenti.
Dorothy proseguì a tempo pieno le ricerche 'sul campo' in Medio Oriente
e in Francia fino al 1969, cioè fino alla morte, avvenuta all'età di
77 anni. Musei di diversi luoghi ricevettero le sue donazioni. Fu
indubbiamente una donna straordinaria. Le mancò solo l'immortalità.
Dorothy Annie Elizabeth
Garrod (1892-1969). Inglese. Si laureò a Oxford ed è considerata una vera
pioniera per la scienza archeologica e di primati ne ha conseguiti tanti. Fu
la prima donna - professore all'Università di Cambridge, nominata il 3
marzo del 1939. Fu la prima ad incorporare la fotografia aerea negli
scavi. E' stata la prima donna a ricevere la medaglia d'oro della
Società di antiquari di Londra. I suoi scavi la videro attiva in
Inghilterra, Palestina, Kurdistan, Bulgaria, Gibilterra e Libano. Spese
molte forze nelle ricerche del Vicino Oriente, in particolar modo ristette due
anni sul Monte Carmelo, dove fece importanti scoperte in campo
paleo-antropologico; fu una pioniera anche in questo.Nelle grotte del Carmelo
ritrovò molti scheletri di Neanderthal, insieme a strumenti vari e
comprese la fondamentale nozione- fino a quel momento ignorata- che il
Neanderthal fosse vissuto anche fuori dall'Europa, cosa che non si
riteneva possibile. Dorothy concluse, dopo attente ricerche, che i
Neanderthals in Europa e nel Vicino Oriente coesistevano, esistevano
cioè nella stessa epoca, anche se quelli in Europa erano più primitivi.
Questo, naturalmente, provocò qualche emozione e anche reazione negativa
perchè scardinava la teoria allora in vigore, circa il concetto di
evoluzione lineare. La Garrod fece fare grandi progressi alla scienza in
diversi campi tra cui l'arte paleolitica, le migrazioni dell'uomo preistorico
e i metodi di irrigazione che impiegava, le tecniche di caccia che usava;
inoltre, analizzando i resti della fauna in vari distretti, fu in grado di
definire chiaramente come anticamente le condizioni climatiche ed ecologiche
dovevano essere mutate. Insegnò all'Università di Cambridge fino al 1952.
Nel 1956 le donne entrarono a pieno titolo nell'Università come docenti.
Dorothy proseguì a tempo pieno le ricerche 'sul campo' in Medio Oriente
e in Francia fino al 1969, cioè fino alla morte, avvenuta all'età di
77 anni. Musei di diversi luoghi ricevettero le sue donazioni. Fu
indubbiamente una donna straordinaria. Le mancò solo l'immortalità.
![]() Harriet Boyd. Americana,
nata nel 1900. E' passata alla storia come la prima donna che diresse
uno scavo archeologico, ancora studentessa, intrepida e avventurosa (ma
certamente anche competente), per conto della American School of Archaelogy.
Con l'amica botanica Jane Patten apprese dalle popolazioni indigene
l'esistenza del ricco sito di Kavousi nella parte meridionale
dell'isola di Creta. Se ne andavano in giro con i loro abitoni lunghi
fino ai piedi, con una sorta di guardia armata (il 'soprastante')e della madre
di costui, destando la curiosità e lo stupore dei primi archeologi, come
quella dell'italiano Halbherr. Solo più tardi le archeologhe avrebbero
indossato i jeans e l'abbigliamento tipico di chi deve muoversi tra sabbie,
mulattiere polverose, cammelli e dorsi di mulo... Questa 'spregiudicatezza'
dell'epoca la dice lunga su come le anglosassoni godessero di maggiore libertà
di azione rispetto alle italiane.
Harriet Boyd. Americana,
nata nel 1900. E' passata alla storia come la prima donna che diresse
uno scavo archeologico, ancora studentessa, intrepida e avventurosa (ma
certamente anche competente), per conto della American School of Archaelogy.
Con l'amica botanica Jane Patten apprese dalle popolazioni indigene
l'esistenza del ricco sito di Kavousi nella parte meridionale
dell'isola di Creta. Se ne andavano in giro con i loro abitoni lunghi
fino ai piedi, con una sorta di guardia armata (il 'soprastante')e della madre
di costui, destando la curiosità e lo stupore dei primi archeologi, come
quella dell'italiano Halbherr. Solo più tardi le archeologhe avrebbero
indossato i jeans e l'abbigliamento tipico di chi deve muoversi tra sabbie,
mulattiere polverose, cammelli e dorsi di mulo... Questa 'spregiudicatezza'
dell'epoca la dice lunga su come le anglosassoni godessero di maggiore libertà
di azione rispetto alle italiane.
![]() Kathleen Kenion
(1906-1978). Inglese, insieme al suo maestro
Mortimer Wheeler, è stata
la prima donna a introdurre lo scavo stratigrafico di un sito archeologico
e introdusse il cosiddetto periodo del "Neolitico pre-eramico" (datato
al 9.500- 7.000 a.C.). Fu una pioniera dell' 'archeologia biblica'
(seguendo le descrizioni veterotestamentarie, è la scienza 'sul campo' tesa a
verificare le corrispondenze archeologiche). Lavorò a Jericho (Gerico),
individuando una cultura intermedia a quelle che già si conoscevano, che
classificò tra il periodo
Natufiano e
quello neolitico ceramico, Ai livelli inferiori di scavo, la Kenion
trovò due livelli neolitici privi di ceramica, che chiamò pre-pottery
neolithic (neolitico pre-ceramico), suddividendolo in due fasi (A e
B), corrispondenti alle fasi Jericho I e Jericho II. Kathleen morì nel 1978,
a 72 anni.
Kathleen Kenion
(1906-1978). Inglese, insieme al suo maestro
Mortimer Wheeler, è stata
la prima donna a introdurre lo scavo stratigrafico di un sito archeologico
e introdusse il cosiddetto periodo del "Neolitico pre-eramico" (datato
al 9.500- 7.000 a.C.). Fu una pioniera dell' 'archeologia biblica'
(seguendo le descrizioni veterotestamentarie, è la scienza 'sul campo' tesa a
verificare le corrispondenze archeologiche). Lavorò a Jericho (Gerico),
individuando una cultura intermedia a quelle che già si conoscevano, che
classificò tra il periodo
Natufiano e
quello neolitico ceramico, Ai livelli inferiori di scavo, la Kenion
trovò due livelli neolitici privi di ceramica, che chiamò pre-pottery
neolithic (neolitico pre-ceramico), suddividendolo in due fasi (A e
B), corrispondenti alle fasi Jericho I e Jericho II. Kathleen morì nel 1978,
a 72 anni.
![]() Mary Leakey (1913-1996).
Pur non essendosi mai laureata, è ritenuta una grande archeologa e
paleoantropologa inglese. Il suo nome da nubile era Mary Douglas Nicol;
nacque a Londra nel 1913 e passò l'adolescenza tra la Dordogna e a Les
Eyzeries dove il padre, che era un pittore paesaggista, amava soggiornare.
Mary mostrò subito un interesse per i siti preistorici ed archeologici ivi
ubicati ma a soli tredici anni perse il padre e rientrò a Londra con la madre,
la quale voleva farle frequentare la scuola cattolica, senza risultati, perchè
Mary era una 'ribelle' per natura e si fece espellere due volte dagli
istituti: La sua mente era tutta rivolta al mondo misterioso e affascinante
dell'archeologia. Infatti si iscrisse alla facoltà di Archeologia e Geologia
dell'università di Cambridge, facendo l'illustratrice per pagarseli. Negli
anni universitari conobbe Louis Seymour Bazett Leakey (1903-1972),
di dieci anni più vecchio di lei, se ne innamorò e si sposarono nel 1936.
La coppia era destinata a lasciare un segno negli annali di storia. Un
anno più tardi partirono per il Kenya, dove avrebbero cominciato a
produrre fondamentali scoperte sui resti fossili ominidi che permise di
evidenziare le tappe più antiche dell'evoluzione umana. Mary condivise
con Louis le ricerche per tutta la vita e non fu mai da meno, compiendo da
sola importanti ritrovamenti, a partire dal primo teschio fossile di un
primate estintosi nel Miocene, che verrà appellato Pro-Consul.
Nel 1959 ritrovarono un cranio ben conservato di Australopiteco
Boisei, detto 'Ziny' che, per le conoscenze del tempo,
rappresentava il più antico resto di ominide noto (di 1.800.000 anni), che li
rese famosi in tutto il mondo. A metà degli anni '60 del Novecento, Mary
decise di stabilirsi nella gola africana di Oldoway, in Tanzania mentre
Louis seguiva altri progetti di ricerca antropologica. Nel 1964 i due
coniugi scoprirono una nuova specie umana, ma più antica dell'Homo
Erectus di 1.000.000 di anni! Era l'Homo Habilis, che era in grado
di scheggiare ciottoli. Chissà quante emozioni avranno provato in quei
frangenti Mary, Louis e la loro picola equipe! Che anni erano quelli! Di
scoperte che si rincorrevano in modo impressionante, riportando fuori dalle
nebbie del passato conoscenze inaspettate e che, grazie ai moderni mezzi di
comunicazione, facevano velocemente il giro del pianeta! Nel 1972 Mary
restò vedova ma continuò a lavorare alle sue ricerche; nel 1974 si
spostò a Laetoli dove fece altre scoperte come file di impronte fossili
di ominidi bipedi 'cementificate' nelle ceneri vulcaniche (note come
'impronte di Laetoli'). Alla soglia dei settant'anni, Mary si ritirò a
Nairobi, abbandonando la ricerca sul campo ma seguendo le notizie che
arrivavano dal mondo della ricerca. Ricevette molte lauree 'ad honerem'
e diversi premi, che coronarono meritatamente la sua carriera di donna che,
non essendosi laureata, riuscì ad imporsi ugualmente quale figura di spicco
della paleoantropologia, non 'solo' come moglie di Louis Laekey ma
distinguendosi per i suoi meriti personali. Morì a 83 anni, nel
1996.
Mary Leakey (1913-1996).
Pur non essendosi mai laureata, è ritenuta una grande archeologa e
paleoantropologa inglese. Il suo nome da nubile era Mary Douglas Nicol;
nacque a Londra nel 1913 e passò l'adolescenza tra la Dordogna e a Les
Eyzeries dove il padre, che era un pittore paesaggista, amava soggiornare.
Mary mostrò subito un interesse per i siti preistorici ed archeologici ivi
ubicati ma a soli tredici anni perse il padre e rientrò a Londra con la madre,
la quale voleva farle frequentare la scuola cattolica, senza risultati, perchè
Mary era una 'ribelle' per natura e si fece espellere due volte dagli
istituti: La sua mente era tutta rivolta al mondo misterioso e affascinante
dell'archeologia. Infatti si iscrisse alla facoltà di Archeologia e Geologia
dell'università di Cambridge, facendo l'illustratrice per pagarseli. Negli
anni universitari conobbe Louis Seymour Bazett Leakey (1903-1972),
di dieci anni più vecchio di lei, se ne innamorò e si sposarono nel 1936.
La coppia era destinata a lasciare un segno negli annali di storia. Un
anno più tardi partirono per il Kenya, dove avrebbero cominciato a
produrre fondamentali scoperte sui resti fossili ominidi che permise di
evidenziare le tappe più antiche dell'evoluzione umana. Mary condivise
con Louis le ricerche per tutta la vita e non fu mai da meno, compiendo da
sola importanti ritrovamenti, a partire dal primo teschio fossile di un
primate estintosi nel Miocene, che verrà appellato Pro-Consul.
Nel 1959 ritrovarono un cranio ben conservato di Australopiteco
Boisei, detto 'Ziny' che, per le conoscenze del tempo,
rappresentava il più antico resto di ominide noto (di 1.800.000 anni), che li
rese famosi in tutto il mondo. A metà degli anni '60 del Novecento, Mary
decise di stabilirsi nella gola africana di Oldoway, in Tanzania mentre
Louis seguiva altri progetti di ricerca antropologica. Nel 1964 i due
coniugi scoprirono una nuova specie umana, ma più antica dell'Homo
Erectus di 1.000.000 di anni! Era l'Homo Habilis, che era in grado
di scheggiare ciottoli. Chissà quante emozioni avranno provato in quei
frangenti Mary, Louis e la loro picola equipe! Che anni erano quelli! Di
scoperte che si rincorrevano in modo impressionante, riportando fuori dalle
nebbie del passato conoscenze inaspettate e che, grazie ai moderni mezzi di
comunicazione, facevano velocemente il giro del pianeta! Nel 1972 Mary
restò vedova ma continuò a lavorare alle sue ricerche; nel 1974 si
spostò a Laetoli dove fece altre scoperte come file di impronte fossili
di ominidi bipedi 'cementificate' nelle ceneri vulcaniche (note come
'impronte di Laetoli'). Alla soglia dei settant'anni, Mary si ritirò a
Nairobi, abbandonando la ricerca sul campo ma seguendo le notizie che
arrivavano dal mondo della ricerca. Ricevette molte lauree 'ad honerem'
e diversi premi, che coronarono meritatamente la sua carriera di donna che,
non essendosi laureata, riuscì ad imporsi ugualmente quale figura di spicco
della paleoantropologia, non 'solo' come moglie di Louis Laekey ma
distinguendosi per i suoi meriti personali. Morì a 83 anni, nel
1996.
L'amaro caso di Medea Norsa, filologa e papirologa italiana
![]() Medea Norsa
(1877-1952). Maria Vittoria Irma Norsa nacque a Trieste, che a quel
tempo era ancora assoggettato all'impero austro-ungarico. Prima di sette
figli, la sua storia, da un
lato brillante e prestigiosa, ne mostra un altro desolante e quasi crudele. La
sua figura merita una riconsiderazione e una rivalutazione sotto tutti i
profili, sia professionale che umano. Per questo cercheremo di raccontarla
brevemente ma incisivamente. Anche se la sua famiglia non aveva mantenuto
rapporti con la comunità ebraica locale, erano di ascendenza ebraico-sefardita
e questo - in seguito- avrebbe contribuito a peggiorare la sua condizione. Ma
la giovane Medea doveva ancora iniziare la vita professionale, che prometteva
molto bene. Dopo gli studi classici, venne consigliata dal suo professore
Adolfo Mussafia a trasferirsi a Firenze, per proseguirli e
perfezionarsi ma fu all'Università fiorentina che incontrò il filologo
Girolamo Vitelli, che la iniziò allo studio della papirologia,
branca scientifica che allora era veramente in embrione. Nel 1906 prese
una laurea in Lettere e già in dicembre venne ammessa al Gabinetto di
Papiri dell'Istituto di Studi Superiori. Unica donna, per quei
tempi, ad essere nominata alla cattedra di Lingua e Letteratura italiana a
Triste, lasciò l'insegnamento nel 1911 per tornare al fianco di
Vitelli, che la richiese per proseguire gli studi sui papiri presso l'Istituto
Papirologico fiorentino, che il professore dirigeva. Era tanto talentuosa
e preparata che ben presto eguagliò le doti del maestro, e quando questi fu
avanti negli anni, si dice che fosse lei a lavorare in sua vece, restando
nell'ombra. Produsse dodici volumi per la Società Italiana di
Papirologia, un lavoro immenso di cui tutti i ricercatori devono
esserle grati. A causa di questa eccessiva dedizione di discepola, forse
inconsapevole delle sue reali capacità, tralasciò la propria carriera
accademica, non entrando mai a pieno titolo nell'organico dell'università
italiana da docente ordinario. Insegnò invece a Firenze e alla
Scuola Normale di Pisa come libera docente. Le venivano affidati compiti
di rilevante responsabilità, come frequenti spostamenti in Egitto per
'trattare' con i mercanti d'arte gli acquisti di papiri, di cui era divenuta
esperta decifratrice; sapeva anche tradurre gli antichi testi greci e latini.
Fino al 1935 godette di grande notorietà, fu stimata e ricercata da
tutta la comunità scientifica e fu membro di prestigiose istituzioni
internazionali. In quell'anno però il Vitelli morì e lei prese il suo posto
alla direzione dell'Istituto Papirologico. Senza il carisma del suo
maestro, Medea si ritrovò però ben presto sempre più isolata, a causa
dell'invidia che suscitava agli occhi dei 'colleghi', che cominciarono a
tollerare male il fatto di esserle subalterni. Lei, una donna nubile, con
quella posizione, era alquanto scomoda e a complicare le cose giunsero, nel
1938, le Leggi razziali. La sua ascendenza ebraica cominciò a
diventare un 'handicap' in quell'epoca di egoismo collettivo; veniva inoltre
considerata 'straniera' (perchè nata sotto l'impero austro-ungarico!). Tutto
ciò ebbe l'effetto di emarginarla e alla luce di queste concise circostanze
possiamo solo immaginare cosa debba aver vissuto nel suo intimo, lei, una
donna così intelligente e schiva, che non aveva mai voluto apparire,
rispettosa del lavoro degli altri e modesta nella sua sapienza. Il suo astro
cominciò a declinare inesorabilmente; nel 1944 la casa dove viveva con
la cognata subì un bombardamento che la distrusse. Sua cognata ci rimise la
vita e Medea, insieme alla disperazione, vide tutta la sua adorata biblioteca
privata andare letteralmente in fumo. Manteneva ancora il posto di lavoro ma
nel 1947 contrasse una malattia che la tenne lontana un anno dalle sue
attività; quando nel 1949 si ristabilì, venne 'congedata' dal Rettore
fiorentino Bruno Borghi. Un'altra umiliazione, un'altro durissimo
colpo, a cui seguì il colpo di grazia. Mentre stava lavorando al tredicesimo
volume per la Società italiana di Papirologi, il collega Terzaghi
glielo sottrasse. Probabilmente non sapendo come difendersi di fronte a tante
onte, sconfitta senza aver mai condotto una vera battaglia, si ritirò in un
convento fiorentino femminile, dove morì, nel 1952, nella dimenticanza
generale, a 75 anni d'età. Oggi viene ricordata come una grande filologa e
papirologa italiana.
Medea Norsa
(1877-1952). Maria Vittoria Irma Norsa nacque a Trieste, che a quel
tempo era ancora assoggettato all'impero austro-ungarico. Prima di sette
figli, la sua storia, da un
lato brillante e prestigiosa, ne mostra un altro desolante e quasi crudele. La
sua figura merita una riconsiderazione e una rivalutazione sotto tutti i
profili, sia professionale che umano. Per questo cercheremo di raccontarla
brevemente ma incisivamente. Anche se la sua famiglia non aveva mantenuto
rapporti con la comunità ebraica locale, erano di ascendenza ebraico-sefardita
e questo - in seguito- avrebbe contribuito a peggiorare la sua condizione. Ma
la giovane Medea doveva ancora iniziare la vita professionale, che prometteva
molto bene. Dopo gli studi classici, venne consigliata dal suo professore
Adolfo Mussafia a trasferirsi a Firenze, per proseguirli e
perfezionarsi ma fu all'Università fiorentina che incontrò il filologo
Girolamo Vitelli, che la iniziò allo studio della papirologia,
branca scientifica che allora era veramente in embrione. Nel 1906 prese
una laurea in Lettere e già in dicembre venne ammessa al Gabinetto di
Papiri dell'Istituto di Studi Superiori. Unica donna, per quei
tempi, ad essere nominata alla cattedra di Lingua e Letteratura italiana a
Triste, lasciò l'insegnamento nel 1911 per tornare al fianco di
Vitelli, che la richiese per proseguire gli studi sui papiri presso l'Istituto
Papirologico fiorentino, che il professore dirigeva. Era tanto talentuosa
e preparata che ben presto eguagliò le doti del maestro, e quando questi fu
avanti negli anni, si dice che fosse lei a lavorare in sua vece, restando
nell'ombra. Produsse dodici volumi per la Società Italiana di
Papirologia, un lavoro immenso di cui tutti i ricercatori devono
esserle grati. A causa di questa eccessiva dedizione di discepola, forse
inconsapevole delle sue reali capacità, tralasciò la propria carriera
accademica, non entrando mai a pieno titolo nell'organico dell'università
italiana da docente ordinario. Insegnò invece a Firenze e alla
Scuola Normale di Pisa come libera docente. Le venivano affidati compiti
di rilevante responsabilità, come frequenti spostamenti in Egitto per
'trattare' con i mercanti d'arte gli acquisti di papiri, di cui era divenuta
esperta decifratrice; sapeva anche tradurre gli antichi testi greci e latini.
Fino al 1935 godette di grande notorietà, fu stimata e ricercata da
tutta la comunità scientifica e fu membro di prestigiose istituzioni
internazionali. In quell'anno però il Vitelli morì e lei prese il suo posto
alla direzione dell'Istituto Papirologico. Senza il carisma del suo
maestro, Medea si ritrovò però ben presto sempre più isolata, a causa
dell'invidia che suscitava agli occhi dei 'colleghi', che cominciarono a
tollerare male il fatto di esserle subalterni. Lei, una donna nubile, con
quella posizione, era alquanto scomoda e a complicare le cose giunsero, nel
1938, le Leggi razziali. La sua ascendenza ebraica cominciò a
diventare un 'handicap' in quell'epoca di egoismo collettivo; veniva inoltre
considerata 'straniera' (perchè nata sotto l'impero austro-ungarico!). Tutto
ciò ebbe l'effetto di emarginarla e alla luce di queste concise circostanze
possiamo solo immaginare cosa debba aver vissuto nel suo intimo, lei, una
donna così intelligente e schiva, che non aveva mai voluto apparire,
rispettosa del lavoro degli altri e modesta nella sua sapienza. Il suo astro
cominciò a declinare inesorabilmente; nel 1944 la casa dove viveva con
la cognata subì un bombardamento che la distrusse. Sua cognata ci rimise la
vita e Medea, insieme alla disperazione, vide tutta la sua adorata biblioteca
privata andare letteralmente in fumo. Manteneva ancora il posto di lavoro ma
nel 1947 contrasse una malattia che la tenne lontana un anno dalle sue
attività; quando nel 1949 si ristabilì, venne 'congedata' dal Rettore
fiorentino Bruno Borghi. Un'altra umiliazione, un'altro durissimo
colpo, a cui seguì il colpo di grazia. Mentre stava lavorando al tredicesimo
volume per la Società italiana di Papirologi, il collega Terzaghi
glielo sottrasse. Probabilmente non sapendo come difendersi di fronte a tante
onte, sconfitta senza aver mai condotto una vera battaglia, si ritirò in un
convento fiorentino femminile, dove morì, nel 1952, nella dimenticanza
generale, a 75 anni d'età. Oggi viene ricordata come una grande filologa e
papirologa italiana.
Archeologhe e ...molto altro:le donne crescono e con loro la scienza!
![]() Grace Crowfoot
(1877-1957). Nacque a Lincolnshire (Inghilterra), prima di sei
figli; il suo nome da nubile era Grace Mary Hood e per amici e parenti
fu sempre 'Molly'. Il suo approccio con il mondo dell'archeologia
avvenne in seguito ad un fatto curioso: alla morte di suo nonno, che era un
collezionista di antichità egiziane, vennero battuti all'asta da Sotheby's i
reperti che possedeva. Ciò permise a Grace di venire in contatto con alcuni
archeologi, tra cui anche Flinders Petrie, il marito di Hilda (vedi
sopra). Completati gli studi a Parigi, svernò a San Remo (Liguria) e partecipò
ad una spedizione botanica sulle Alpi Liguri; scavò la grotta a Tana
Bertrand nel 1908 -'09, facendone poi un resoconto scritto. Nel
1909 sposò un giovane assistente direttore dell'Istituto
dell'Educazione nel Sudan, Winter Crowfoot, da cui attinse il
cognome. Nel 1910 vennero mandati al Cairo per impegni professionali;
qui ebbero tre figlie. Molly imparò la tecnica della fotografia e realizzò
diversi lavori sui fiori del deserto, ma allo scoppio della I Guerra Mondiale
ripararono nuovamente in Sudan dove Molly divenne esperta di epigrafia e
rilievo delle tombe faraoniche. Dopo la nascita della quarta figlia e la fine
del conflitto bellico, decisero di rientrare in Inghilterra. Vediamo come
questa donna coraggiosa, con le sue 4 bambine e avendo perso tutti i suoi
fratelli durante la guerra, non pensò di mettersi a fare la mamma a tempo
pieno ma incrementò le proprie energie al servizio della cultura. Divenne
membro della Lega delle Nazioni Unite; pubblicò diversi libri a
carattere archeologico, ma anche botanico (che era una delle sue passioni),
con le sue fotografie. Ma il bello doveva ancora arrivare. Quando il marito
venne messo a capo di diversi scavi, in qualità di direttore della Scuola
Britannica di Archeologia a Gerusalemme, Molly mise in mostra le
sue qualità
di organizzatrice degli scavi, dal quartier generale! Con l'avvento della II
Guerra Mondiale tornò in Inghilterra (due conflitti bellici nella sua vita) e
lavorò al Sutton Hoo Ship; pubblicò anche i risultati delle ricerche
condotte nella tomba di Tuthankamon. Con la scoperta dei Rotoli del Mar
Morto, Molly pubblicò un articolo sul Qumran Textile,
affascinando e stimolando una generazione di archeologi prima che la morte la
rapisse, a 80 anni e per leucemia, nel 1957.
Grace Crowfoot
(1877-1957). Nacque a Lincolnshire (Inghilterra), prima di sei
figli; il suo nome da nubile era Grace Mary Hood e per amici e parenti
fu sempre 'Molly'. Il suo approccio con il mondo dell'archeologia
avvenne in seguito ad un fatto curioso: alla morte di suo nonno, che era un
collezionista di antichità egiziane, vennero battuti all'asta da Sotheby's i
reperti che possedeva. Ciò permise a Grace di venire in contatto con alcuni
archeologi, tra cui anche Flinders Petrie, il marito di Hilda (vedi
sopra). Completati gli studi a Parigi, svernò a San Remo (Liguria) e partecipò
ad una spedizione botanica sulle Alpi Liguri; scavò la grotta a Tana
Bertrand nel 1908 -'09, facendone poi un resoconto scritto. Nel
1909 sposò un giovane assistente direttore dell'Istituto
dell'Educazione nel Sudan, Winter Crowfoot, da cui attinse il
cognome. Nel 1910 vennero mandati al Cairo per impegni professionali;
qui ebbero tre figlie. Molly imparò la tecnica della fotografia e realizzò
diversi lavori sui fiori del deserto, ma allo scoppio della I Guerra Mondiale
ripararono nuovamente in Sudan dove Molly divenne esperta di epigrafia e
rilievo delle tombe faraoniche. Dopo la nascita della quarta figlia e la fine
del conflitto bellico, decisero di rientrare in Inghilterra. Vediamo come
questa donna coraggiosa, con le sue 4 bambine e avendo perso tutti i suoi
fratelli durante la guerra, non pensò di mettersi a fare la mamma a tempo
pieno ma incrementò le proprie energie al servizio della cultura. Divenne
membro della Lega delle Nazioni Unite; pubblicò diversi libri a
carattere archeologico, ma anche botanico (che era una delle sue passioni),
con le sue fotografie. Ma il bello doveva ancora arrivare. Quando il marito
venne messo a capo di diversi scavi, in qualità di direttore della Scuola
Britannica di Archeologia a Gerusalemme, Molly mise in mostra le
sue qualità
di organizzatrice degli scavi, dal quartier generale! Con l'avvento della II
Guerra Mondiale tornò in Inghilterra (due conflitti bellici nella sua vita) e
lavorò al Sutton Hoo Ship; pubblicò anche i risultati delle ricerche
condotte nella tomba di Tuthankamon. Con la scoperta dei Rotoli del Mar
Morto, Molly pubblicò un articolo sul Qumran Textile,
affascinando e stimolando una generazione di archeologi prima che la morte la
rapisse, a 80 anni e per leucemia, nel 1957.
![]() Gertrude Caton- Thompson
(1888-1985). Nacque a Londra e ricevette un'istruzione in scuole
private, perfezionandosi in Francia. A ventitrè anni fece un viaggio in Egitto
con la madre e qui scoccò il suo primo interesse per l'archeologia.
Probabilmente vide all'opera qualche donna che, pionieristicamente, muoveva i
primi passi negli scavi dei siti egiziani e ne restò influenzata al punto che
decise che la sua strada doveva essere quella. Già nel 1919 la troviamo
a lavorare nel sito di Abydos e a Oxyrhinchus, portando a
completamento gli studi alla British School of Archeology in Egypt tra
il 1924 -'26. Fu allieva di Flinders Petrie alla College
University di Londra. Insieme al geologo Elinor Wight
Garner divennero la prima SURVEY archeologa nel Fayum
settentrionale. Lavorò in altri siti, nell'oasi di Kharga, in Medio Oriente e
nell'Africa meridionale dove, tra il 1928-'29 scavò le rovine di
Great Zimbabwe, arrivando a postulare che fosse quella la terra
d'origine della specie umana. Ricoprì incarichi di elevato prestigio e iniziò,
con altri due colleghi, lo scavo sistematico dello Yemen. La sua vita
avventurosa e instancabile si concluse nel 1995 a 97 anni a Broadway,
nel Worcestershire, dopo aver attraversato la storia a cavallo di due secoli e
aver assistito a tante scoperte rivoluzionarie.
Gertrude Caton- Thompson
(1888-1985). Nacque a Londra e ricevette un'istruzione in scuole
private, perfezionandosi in Francia. A ventitrè anni fece un viaggio in Egitto
con la madre e qui scoccò il suo primo interesse per l'archeologia.
Probabilmente vide all'opera qualche donna che, pionieristicamente, muoveva i
primi passi negli scavi dei siti egiziani e ne restò influenzata al punto che
decise che la sua strada doveva essere quella. Già nel 1919 la troviamo
a lavorare nel sito di Abydos e a Oxyrhinchus, portando a
completamento gli studi alla British School of Archeology in Egypt tra
il 1924 -'26. Fu allieva di Flinders Petrie alla College
University di Londra. Insieme al geologo Elinor Wight
Garner divennero la prima SURVEY archeologa nel Fayum
settentrionale. Lavorò in altri siti, nell'oasi di Kharga, in Medio Oriente e
nell'Africa meridionale dove, tra il 1928-'29 scavò le rovine di
Great Zimbabwe, arrivando a postulare che fosse quella la terra
d'origine della specie umana. Ricoprì incarichi di elevato prestigio e iniziò,
con altri due colleghi, lo scavo sistematico dello Yemen. La sua vita
avventurosa e instancabile si concluse nel 1995 a 97 anni a Broadway,
nel Worcestershire, dopo aver attraversato la storia a cavallo di due secoli e
aver assistito a tante scoperte rivoluzionarie.
![]() Luisa Banti (1894- 1978).
Nacque a Firenze e si laureò nella sua città. Fu attiva nel 1930
a Creta con la Missione Archeologica Italiana; pubblicò le precoci
scoperte al Palazzo Minoico di Festos collaborando con il prof.
L. Pernier. Si distinse per la sua attività di ricerca in campo etrusco,
essendone stata indirizzata dal prof. G. Devoto e ricoprì incarichi di
alto livello come la presidenza dell'Istituto di Etruscologia dal
1965 al 1972. Il suo lavoro più conosciuto, tradotto in diverse lingue,
è "Il mondo degli Etruschi". Morì a 84 anni, nel
1978.
Luisa Banti (1894- 1978).
Nacque a Firenze e si laureò nella sua città. Fu attiva nel 1930
a Creta con la Missione Archeologica Italiana; pubblicò le precoci
scoperte al Palazzo Minoico di Festos collaborando con il prof.
L. Pernier. Si distinse per la sua attività di ricerca in campo etrusco,
essendone stata indirizzata dal prof. G. Devoto e ricoprì incarichi di
alto livello come la presidenza dell'Istituto di Etruscologia dal
1965 al 1972. Il suo lavoro più conosciuto, tradotto in diverse lingue,
è "Il mondo degli Etruschi". Morì a 84 anni, nel
1978.
![]() Bruna Tamaro
(1894-1990). Nacque nello stesso anno di Luisa, il 1884, ma nel
profondo nord padano, a Grumello del Monte, piccolo paese in provincia di Bergamo.
Si spostò dappèrima a Bologna per ragioni di studio e nel 1915 era già laureata in
Filologia classica presso l'università di Genova; proseguì poi i
suoi studi in archeologia a Roma ed Atene. Ricoprì l'incarico di
Ispettore Archeologico per Venezia dal 1921 al 1936 e
nella città lagunare incontrò nel 1929 il suo futuro marito,
Ferdinando Forlati, allora Soprintendente ai Monumenti per la regione
Trieste (si ricordi la situazione politica del tempo), dal quale ebbe un
figlio. Dal 1952 al 1961 Bruna fu direttrice del Museo Archeologico
di Venezia, in seguito divenne Soprintendente ai Monumenti di Padova,
città che le permise di perfezionare i suoi studi. Nel 1961 partecipò
agli scavi in Israele, a Cesarea, e ben presto la sua figura
venne richiesta nelle maggiori Commissioni relative alla gestione del
patrimonio storico-culturale, non solo italiano ma internazionale. Fu membro
dell'Istituto Imperiale Archeologico Germanico, dell'Istituto
di Studi Etruschi, dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria,
e di molti altri. Produsse tre volumi in cui spiegò le basi della
preservazione del patrimonio storico nazionale, in qualità di esperta delle
questioni museali e curatrice di molti progetti di restauro (Verona, Venezia,
Istria, Trieste, etc.). Si spense dopo un'intensa vita spesa al servizio della
cultura, nel 1990, a 96 anni.
Bruna Tamaro
(1894-1990). Nacque nello stesso anno di Luisa, il 1884, ma nel
profondo nord padano, a Grumello del Monte, piccolo paese in provincia di Bergamo.
Si spostò dappèrima a Bologna per ragioni di studio e nel 1915 era già laureata in
Filologia classica presso l'università di Genova; proseguì poi i
suoi studi in archeologia a Roma ed Atene. Ricoprì l'incarico di
Ispettore Archeologico per Venezia dal 1921 al 1936 e
nella città lagunare incontrò nel 1929 il suo futuro marito,
Ferdinando Forlati, allora Soprintendente ai Monumenti per la regione
Trieste (si ricordi la situazione politica del tempo), dal quale ebbe un
figlio. Dal 1952 al 1961 Bruna fu direttrice del Museo Archeologico
di Venezia, in seguito divenne Soprintendente ai Monumenti di Padova,
città che le permise di perfezionare i suoi studi. Nel 1961 partecipò
agli scavi in Israele, a Cesarea, e ben presto la sua figura
venne richiesta nelle maggiori Commissioni relative alla gestione del
patrimonio storico-culturale, non solo italiano ma internazionale. Fu membro
dell'Istituto Imperiale Archeologico Germanico, dell'Istituto
di Studi Etruschi, dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria,
e di molti altri. Produsse tre volumi in cui spiegò le basi della
preservazione del patrimonio storico nazionale, in qualità di esperta delle
questioni museali e curatrice di molti progetti di restauro (Verona, Venezia,
Istria, Trieste, etc.). Si spense dopo un'intensa vita spesa al servizio della
cultura, nel 1990, a 96 anni.
![]() Paola Montuoro
(1901-1987). Nacque a Napoli e si laureò nel 1923. Giunta ad
Atene alla Scuola Italiana di Archeologia, sposò un suo studente,
Domenico Zancani, che però morì precocemente a causa del tifo.
Insegnante all'università di Napoli, Paola si interessò ai siti archeologici
della Magna Grecia, di Sibari, Paestum e di Locri. Scoprì, tra mille
difficoltà, il tempio di
Hera Argiva con Umberto Zanotti Bianco. Esperta nell'iconografia
scultorea, fece studi sulle metope di Selinunte, dell'isola di Mozia
e molti altri. Dopo una lunga e fruttuosa carriera, avendo all'attivo
moltissime pubblicazioni e aver ricevuto numerosi premi, morì a Sorrento, nel
1987, a 86 anni.
Paola Montuoro
(1901-1987). Nacque a Napoli e si laureò nel 1923. Giunta ad
Atene alla Scuola Italiana di Archeologia, sposò un suo studente,
Domenico Zancani, che però morì precocemente a causa del tifo.
Insegnante all'università di Napoli, Paola si interessò ai siti archeologici
della Magna Grecia, di Sibari, Paestum e di Locri. Scoprì, tra mille
difficoltà, il tempio di
Hera Argiva con Umberto Zanotti Bianco. Esperta nell'iconografia
scultorea, fece studi sulle metope di Selinunte, dell'isola di Mozia
e molti altri. Dopo una lunga e fruttuosa carriera, avendo all'attivo
moltissime pubblicazioni e aver ricevuto numerosi premi, morì a Sorrento, nel
1987, a 86 anni.
![]() Lucia Guerrini
(1921-1990). Nacque a Lodi. Compiuti gli studi sotto la direzione del
prof. Sergio Donadoni, diede gli esami in arte copta nel 1954
a Milano. Tre anni dopo partecipò agli scavi minoici a Festos.
Rientrata in Italia, si recò a Roma, dove venne influenzata dagli
studi del prof. Ranuccio Bianchi Bandinelli e nel '58 si dedicò
alla stesura di una poderosa opera, l'Enciclopedia Italiana di arte
classica e orientale. Nel 1964 divenne docente all'università
romana, recandosi però spesso in Egitto per seguire le ricerche che la
appassionavano relative all'arte copta. Nel 1965 partecipò agli scavi
di Antinoe, producendo innumerevoli pubblicazioni. Morì nella sua città
natale, nel 1990, a 69 anni.
Lucia Guerrini
(1921-1990). Nacque a Lodi. Compiuti gli studi sotto la direzione del
prof. Sergio Donadoni, diede gli esami in arte copta nel 1954
a Milano. Tre anni dopo partecipò agli scavi minoici a Festos.
Rientrata in Italia, si recò a Roma, dove venne influenzata dagli
studi del prof. Ranuccio Bianchi Bandinelli e nel '58 si dedicò
alla stesura di una poderosa opera, l'Enciclopedia Italiana di arte
classica e orientale. Nel 1964 divenne docente all'università
romana, recandosi però spesso in Egitto per seguire le ricerche che la
appassionavano relative all'arte copta. Nel 1965 partecipò agli scavi
di Antinoe, producendo innumerevoli pubblicazioni. Morì nella sua città
natale, nel 1990, a 69 anni.
![]() Michela Schiff-Giorgini
(1923-1978). Nacque a Padova e nonostante non si fosse mai laureata, fu
anche lei una personalità di spicco nell'archeologia egiziana e per la sua
infaticabile attività ricevette nel 1971 una laurea 'honoris causa' in
Lettere e Filosofia presso l'Università di Pisa, ateneo per il quale
aveva lavorato per vent'anni, dal 1957 al 1977. Sotto quel Patronato
aveva partecipato agli scavi del tempio di Soleb e a quello di Amenhotep III,
alle tombe della XVIII dinastia a Sedenga, presso il tempio della regina Tiy,
moglie di Amenhotep III, scavò la tomba di Taharqa, faraone kushita della 25^
dinastia. Moglie di Giorgio Giorgini Paleologo Diana (nome tecnico
Schiff-Giorgini), da cui attinse il cognome, ricevette nel 1961 la
medaglia d'argento delle Relazioni Culturali da parte del Ministero degli
Esteri italiano; nel 1964 la medaglia d'argento dall'Ateneo pisano.
Michela rivelò doti di abile scrittrice e divulgatrice scientifica pubblicando
articoli esaustivi su riviste specializzate e fu inoltre autrice di volumi
inerenti gli scavi del tempio di Soleb, da quando erano cominciati (nel 1813)
fino al 1963. Tutto il materiale che aveva ritrovato negli scavi e che le era
stato assegnato dal Ministero dell'Educazione Nazionale del Sudan, lo
donò all'università di Pisa; quella collezione porta il suo nome ed è
conservata in un locale di Palazzo Ricci a Pisa. Fece dono anche di tutto
quanto era attinente agli scavi stessi, come disegni, carteggi, fotografie,
diari, filmati. Materiale preziosissimo. Nel 1971 fu proposta, a
Parigi, per il grado di Cavaliere nell'Ordine della "Palmes acadèmiques",
una grande onorificenza. Si ritirò in Spagna dove morì di meningite, il
3 luglio del 1978, all'età di 55 anni.
Michela Schiff-Giorgini
(1923-1978). Nacque a Padova e nonostante non si fosse mai laureata, fu
anche lei una personalità di spicco nell'archeologia egiziana e per la sua
infaticabile attività ricevette nel 1971 una laurea 'honoris causa' in
Lettere e Filosofia presso l'Università di Pisa, ateneo per il quale
aveva lavorato per vent'anni, dal 1957 al 1977. Sotto quel Patronato
aveva partecipato agli scavi del tempio di Soleb e a quello di Amenhotep III,
alle tombe della XVIII dinastia a Sedenga, presso il tempio della regina Tiy,
moglie di Amenhotep III, scavò la tomba di Taharqa, faraone kushita della 25^
dinastia. Moglie di Giorgio Giorgini Paleologo Diana (nome tecnico
Schiff-Giorgini), da cui attinse il cognome, ricevette nel 1961 la
medaglia d'argento delle Relazioni Culturali da parte del Ministero degli
Esteri italiano; nel 1964 la medaglia d'argento dall'Ateneo pisano.
Michela rivelò doti di abile scrittrice e divulgatrice scientifica pubblicando
articoli esaustivi su riviste specializzate e fu inoltre autrice di volumi
inerenti gli scavi del tempio di Soleb, da quando erano cominciati (nel 1813)
fino al 1963. Tutto il materiale che aveva ritrovato negli scavi e che le era
stato assegnato dal Ministero dell'Educazione Nazionale del Sudan, lo
donò all'università di Pisa; quella collezione porta il suo nome ed è
conservata in un locale di Palazzo Ricci a Pisa. Fece dono anche di tutto
quanto era attinente agli scavi stessi, come disegni, carteggi, fotografie,
diari, filmati. Materiale preziosissimo. Nel 1971 fu proposta, a
Parigi, per il grado di Cavaliere nell'Ordine della "Palmes acadèmiques",
una grande onorificenza. Si ritirò in Spagna dove morì di meningite, il
3 luglio del 1978, all'età di 55 anni.
![]() Alessandra Vaccaro
(1940-2000). Nacque a Roma, dove si laureò con il prof. Ranuccio
Bianchi Bandinelli; in seguito, nel 1964, si trasferì ad Atene
dove frequentò la Scuola di Archeologia Italiana. Sposando l'avvocato
Gianfranco Melucco, il suo nome divenne noto come Alessandra Melucco
Vaccaro. Ci sarebbe da scrivere moltissimo su questa figura di donna
poliedrica, un'intellettuale sensibile e generosa professionista. Così viene
descritta da chi l'ha conosciuta. Scavò il tempio di Pyrgi e, dal
1970 al '74 diresse gli scavi nel duomo vecchio di Arezzo e
nelle necropoli di Chiusi-Arcisa, di cui pubblicò il materiale
ritrovato; lavorò come restauratrice a Paestum, in siti archeologici in
Sardegna, a Reggio Calabria e ai famosi Bronzi di Riace.
Esperta in conservazione e restauro archeologico, fu archeologa per il
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e, a livello internazionale, ha
servito l'UNESCO come esperta del patrimonio culturale mondiale. E' stata
rappresentante per l'Italia della AGESA (Atelier de Gestion des Sites
Archèologique); è stata membro del Bureau du Conseil de la Cooperation
Culturelle (BDCC) per il Consiglio d'Europa; esperta nel Consiglio
d'Europa per il patrimonio. E' stata anche consulente del Centro per la
Conservazione della Fondazione americana Getty. La sua filosofia
era basata sull'uso di metodi non invasivi e interventi conservativi minimi
per la conservazione del patrimonio culturale; pubblicò molti lavori sulla
conservazione della pietra e sulle patine, sulle vernici usate nei manufatti
antichi. Nel 1971 mise in campo la propria competenza all'Istituto
Centrale del Restauro (ICR).Nel 1974 divenne direttore del Museo
dell'Alto Medievo a Roma e produsse svariate opere sul periodo medievale,
tra cui l'importante volume "I Longobardi in Italia",
considerato ancora oggi una risorsa fondamentale bibliografica. Mastering in 5
lingue, dal 1976 al '79 fu deputato al Parlamento italiano nelle liste
dell'allora PCI. Come riuscisse a conciliare tutte le sue prestigiose attività
e a farle tutte valentemente, può sembrare un mistero, ma non lo era per
Alessandra, che a soli sessant'anni però morì, a Roma, nel 2000. L'anno
seguente l'allora Presidente della Repubblica C. A. Ciampi le conferì
la medaglia d'oro della Repubblica italiana al merito (postuma).
Alessandra Vaccaro
(1940-2000). Nacque a Roma, dove si laureò con il prof. Ranuccio
Bianchi Bandinelli; in seguito, nel 1964, si trasferì ad Atene
dove frequentò la Scuola di Archeologia Italiana. Sposando l'avvocato
Gianfranco Melucco, il suo nome divenne noto come Alessandra Melucco
Vaccaro. Ci sarebbe da scrivere moltissimo su questa figura di donna
poliedrica, un'intellettuale sensibile e generosa professionista. Così viene
descritta da chi l'ha conosciuta. Scavò il tempio di Pyrgi e, dal
1970 al '74 diresse gli scavi nel duomo vecchio di Arezzo e
nelle necropoli di Chiusi-Arcisa, di cui pubblicò il materiale
ritrovato; lavorò come restauratrice a Paestum, in siti archeologici in
Sardegna, a Reggio Calabria e ai famosi Bronzi di Riace.
Esperta in conservazione e restauro archeologico, fu archeologa per il
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e, a livello internazionale, ha
servito l'UNESCO come esperta del patrimonio culturale mondiale. E' stata
rappresentante per l'Italia della AGESA (Atelier de Gestion des Sites
Archèologique); è stata membro del Bureau du Conseil de la Cooperation
Culturelle (BDCC) per il Consiglio d'Europa; esperta nel Consiglio
d'Europa per il patrimonio. E' stata anche consulente del Centro per la
Conservazione della Fondazione americana Getty. La sua filosofia
era basata sull'uso di metodi non invasivi e interventi conservativi minimi
per la conservazione del patrimonio culturale; pubblicò molti lavori sulla
conservazione della pietra e sulle patine, sulle vernici usate nei manufatti
antichi. Nel 1971 mise in campo la propria competenza all'Istituto
Centrale del Restauro (ICR).Nel 1974 divenne direttore del Museo
dell'Alto Medievo a Roma e produsse svariate opere sul periodo medievale,
tra cui l'importante volume "I Longobardi in Italia",
considerato ancora oggi una risorsa fondamentale bibliografica. Mastering in 5
lingue, dal 1976 al '79 fu deputato al Parlamento italiano nelle liste
dell'allora PCI. Come riuscisse a conciliare tutte le sue prestigiose attività
e a farle tutte valentemente, può sembrare un mistero, ma non lo era per
Alessandra, che a soli sessant'anni però morì, a Roma, nel 2000. L'anno
seguente l'allora Presidente della Repubblica C. A. Ciampi le conferì
la medaglia d'oro della Repubblica italiana al merito (postuma).
![]() La lista di nomi
prestigiosi di donne sublimi che hanno lasciato una traccia indelebile nella
storia dell'archeologia, e delle sue branche di specializzazione, sembra
interminabile. Citeremo ancora la grande
Iole
Bovio Marconi, nata a Roma ma approdata in Sicilia negli anni
´20 del XX secolo per rimanervi a vita. Fino al 1960 diresse la
Soprintendenza archeologica della Sicilia Occidentale e il Museo
Archeologico Nazionale di Palermo, dove continuò a lavorare anche
durante i bombardamenti e, dopo la guerra, ricostruì il museo stesso (morì nel
1986 in tarda età).
Anna Maria Bisi, che iniziò la sua
carriera di archeologa a Roma con il prof.
Sabatino Moscati. A sua
volta divenne docente universitaria alla Sapienza di Roma e ancora
giovanissima fu nominata Ispettrice delle Antichità Orientali della
Soprintendenza delle Antichità di Palermo. La sua
instancabile attività la vide, nel 1969, insegnante delle Antichità
Puniche e in parallelo pubblicò materiale sui ritrovamenti degli scavi
archeologici; nel 1970 venne incaricata dell'Ufficio Scavi all'Herculaneum;
continuò a pubblicare le sue ricerche fenicie e puniche e al contempo
ricevette la nomina di insegnamento dell'Antico Vicino Oriente all'Università
di Urbino. La sua inaspettata morte, avvenuta nel 1990, fu una
devastante perdita per il mondo della ricerca.
Margherita Guarducci
(1902-1999) nacque a Firenze e si laureò nel
1924 all'Università di
Bologna, perfezionando i suoi studi a Roma, Atene e in Germania. Docente di
Epigrafia e Antichità Greche all'università 'La Sapienza' di Roma, fu membro
della prestigiosa Accademia dei Lincei, della inglese British
Academy e della Mainzer Akademie in Germania ed altre, sia in
Italia che all'estero. Autrice di poderosi volumi a carattere scientifico come
le 'Inscriptiones Creticae' (1935-1950), da lei raccolte durante il suo
lungo periodo di indagini a Creta, e i quattro di 'Epigrafia greca'
(1967-1987), si è distinta per la sua attività in Vaticano dal 1952,
culminata con la decifrazione dei graffiti cristiani sotto l'altare della
Confessione nella basilica di San Pietro e soprattutto della tomba e delle
reliquie di San Pietro. E'scomparsa nel 1999 all'età di 97 anni.
La lista di nomi
prestigiosi di donne sublimi che hanno lasciato una traccia indelebile nella
storia dell'archeologia, e delle sue branche di specializzazione, sembra
interminabile. Citeremo ancora la grande
Iole
Bovio Marconi, nata a Roma ma approdata in Sicilia negli anni
´20 del XX secolo per rimanervi a vita. Fino al 1960 diresse la
Soprintendenza archeologica della Sicilia Occidentale e il Museo
Archeologico Nazionale di Palermo, dove continuò a lavorare anche
durante i bombardamenti e, dopo la guerra, ricostruì il museo stesso (morì nel
1986 in tarda età).
Anna Maria Bisi, che iniziò la sua
carriera di archeologa a Roma con il prof.
Sabatino Moscati. A sua
volta divenne docente universitaria alla Sapienza di Roma e ancora
giovanissima fu nominata Ispettrice delle Antichità Orientali della
Soprintendenza delle Antichità di Palermo. La sua
instancabile attività la vide, nel 1969, insegnante delle Antichità
Puniche e in parallelo pubblicò materiale sui ritrovamenti degli scavi
archeologici; nel 1970 venne incaricata dell'Ufficio Scavi all'Herculaneum;
continuò a pubblicare le sue ricerche fenicie e puniche e al contempo
ricevette la nomina di insegnamento dell'Antico Vicino Oriente all'Università
di Urbino. La sua inaspettata morte, avvenuta nel 1990, fu una
devastante perdita per il mondo della ricerca.
Margherita Guarducci
(1902-1999) nacque a Firenze e si laureò nel
1924 all'Università di
Bologna, perfezionando i suoi studi a Roma, Atene e in Germania. Docente di
Epigrafia e Antichità Greche all'università 'La Sapienza' di Roma, fu membro
della prestigiosa Accademia dei Lincei, della inglese British
Academy e della Mainzer Akademie in Germania ed altre, sia in
Italia che all'estero. Autrice di poderosi volumi a carattere scientifico come
le 'Inscriptiones Creticae' (1935-1950), da lei raccolte durante il suo
lungo periodo di indagini a Creta, e i quattro di 'Epigrafia greca'
(1967-1987), si è distinta per la sua attività in Vaticano dal 1952,
culminata con la decifrazione dei graffiti cristiani sotto l'altare della
Confessione nella basilica di San Pietro e soprattutto della tomba e delle
reliquie di San Pietro. E'scomparsa nel 1999 all'età di 97 anni.
Piccola parentesi: come abbiamo visto, tutte o quasi queste grandi figure femminili sono state longeve, alcune molto longeve. Segno che forse- svolgendo un'attività che le assorbiva e gratificava - sono riuscite a stare in un equilibrio omeostatico che ha consentito loro di vivere in armonia con se stesse e con il loro mondo, pur tra mille difficoltà che possiamo solo immaginare. A tutte le donne archeologhe qui presentate e anche a quelle che per ovvie ragioni non abbiamo potuto includere, rivolgiamo un postumo Pensiero, un tenero Ricordo e insieme la nostra gratitudine e la nostra ammirazione. A quelle che oggi continuano, sul loro esempio, ad essere modello di intelligenza, impegno e determinazione, auguriamo di continuare a farlo sempre con mente aperta perchè nulla di ciò che conosciamo oggi è destinato a rimanere immutabile.
Bibliografia e webgrafia:
![]() Giovanna
Bandini in "Le donne fanno le archeologhe" (pubb.12/10/2007) dossier,
in
http://62.77.55.137/site/Scuola/Zoom/archeiologia/9.htm
Giovanna
Bandini in "Le donne fanno le archeologhe" (pubb.12/10/2007) dossier,
in
http://62.77.55.137/site/Scuola/Zoom/archeiologia/9.htm
![]() "Breaking Ground.
Pioneering Women Archaeologists, Biographies of twelve often-overlooked woman
archaeologists" Getzel M. Cohen and Martha Sharp Joukowsky, Editors -
University of Michigan Press, 2004
"Breaking Ground.
Pioneering Women Archaeologists, Biographies of twelve often-overlooked woman
archaeologists" Getzel M. Cohen and Martha Sharp Joukowsky, Editors -
University of Michigan Press, 2004
![]() http://www.brown.edu/Research/Breaking_Ground/introduction.php
http://www.brown.edu/Research/Breaking_Ground/introduction.php
![]() http://www.mnsu.edu/emuseum/information/biography/fghij/garrod_dorothy.html
http://www.mnsu.edu/emuseum/information/biography/fghij/garrod_dorothy.html
![]() http://it.wikipedia.org/wiki/Kathleen_Kenyon
http://it.wikipedia.org/wiki/Kathleen_Kenyon
![]() http://it.wikipedia.org/wiki/Ersilia_Caetani_Lovatelli
http://it.wikipedia.org/wiki/Ersilia_Caetani_Lovatelli
![]() http://it.wikipedia.org/wiki/Medea_Norsa
http://it.wikipedia.org/wiki/Medea_Norsa
![]() http://www.donneconoscenzastorica.it/testi/recensioni/frecclettere.htm
http://www.donneconoscenzastorica.it/testi/recensioni/frecclettere.htm
Sezioni correlate in questo sito:
www.duepassinelmistero.com Avvertenze/Disclaimer
Marzo 2009