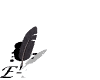TEMATICHE:
Due passi nell'Italia nascosta
Simbologia e Cultura Orientale
UTILITY:
Ricerca veloce titoli per argomento
SERVIZI:
LA
SPIRITUALITA’ PRIMITIVA
*Rapporti
tra magia, spiritualismo, religione, scienza
*Origine
del senso magico
*Il
mito, tra magia e religione
*Conclusione
2. Le religioni
tradizionali d’Africa
*Habitat
e religione
*L’Essere
supremo: nomi, natura e relazioni con il mondo umano
*I
mediatori
*Le
forze negative
*Il
culto
*Conclusione
3. Appendice: alcuni miti
e racconti africani
- La
nascita del pensiero primitivo, rapporti tra magia e religione:
il saggio di Giuseppe Masi
(“Lo
spirito magico. Saggi sul pensiero primitivo”, CLUEB Bologna, 1999)
RAPPORTI
TRA MAGIA, SPIRITUALISMO, RELIGIONE, SCIENZA
La magia, o pensiero magico, si
considera di fronte allo spiritualismo vero e proprio, appartenente a una fase
ben più evoluta del pensiero umano, più come uno spiritismo
(in quanto basato sulla credenza nell’esistenza di uno “spirito” o spiriti
nella natura). Il termine spiritismo ha acquistato con il tempo un significato
esoterico, di carattere soprannaturale, anziché naturale (magico) come quello
considerato qui. Anche il termine “spirito” ha nel pensiero primitivo un
significato molto diverso da quello che acquisterà in seguito nel pensiero
riflesso più evoluto. Esso non si riferisce all’uomo, ma alla natura, a
quanto di misterioso agisce in essa e con cui l’uomo deve confrontarsi ogni
giorno. In questo senso il termine “spirito” ha un significato pluralistico:
il mondo oggettivo, la natura, è popolato da spiriti, cioè forze anonime,
molte delle quali non identificabili, legate a particolari aspetti della natura
(acque, foreste, ecc), che l’uomo, solo e inerme, si sforza di rendere amiche
o di combattere. Ecco allora il mago e la magia: un modo di operare per vie
eccezionali, così come eccezionale si presenta la figura del mago. Nel contesto
sociale la sua figura è, almeno all’inizio, quella di un individuo
d’eccezione, un isolato, in un certo senso un anomalo, che però proprio
grazie ai suoi poteri straordinari, veri o presunti, la società adotta in vista
della propria conservazione. L’apparire del mago nella società primitiva
umana è in relazione al sorgere di una mentalità razionale, perché appunto
egli è impegnato a combattere l’irrazionale, nello sforzo continuo, se non di
comprenderlo, almeno di individuarlo, dandogli un nome ovvero un barlume di
personalità. “Denominare” è già, in un certo senso, “dominare”, cioè
riconoscere qualcosa per quello che è, o si suppone che sia. Questo tentativo
di concettualizzazione corrisponde al primo sforzo speculativo dell’uomo nel
cercare di rendersi conto del mondo, della natura che lo circonda. Più tardi,
sarà lo sforzo di rendersi conto di sé, della propria
natura, destinata poi a divenire prerogativa anche della divinità, cioè di
quella parte dell’ineffabile a cui si tenta di dare un volto, una personalità.
Con il sorgere della religione, la magia non cessa di operare, ma continua in
una forma di subordinazione, come al suo sevizio. Anche l’elaborazione del mito
appartiene a questa fase, in cui l’eterno sforzo dell’uomo di dominare la
natura si compie con la fantasia, oltre che con la tecnica, con la scienza e la
religione.
Il problema fondamentale
allora riguarda anche la religione, perché la magia si può considerare una
prima forma, ancora rozzamente delineata, di religione, e perché quest’ultima
non è che l’esplicitazione, in senso personalizzato e trascendente, di quel
“sacro” legato ancora alle forze naturali, che la magia pretenderebbe di
esorcizzare o di dominare. Questa
pretesa di dominio sulla natura è la velleità essenziale della magia, che in
questo anticipa la scienza, così come anche nell’idea che per cercare di
dominare qualcosa bisogna prima conoscerla, o averne almeno una percezione. Da
ciò deriva quell’atteggiamento in un certo modo ambiguo della magia nei
confronti della natura: amica-nemica da lusingare per poterla poi vincere o
dominare. E’ questo duplice e ambivalente atteggiamento che caratterizza il
“sentimento del sacro”, che dal canto suo anticipa quello della religione
vera e propria, in cui il sacro assume ormai una dimensione specifica e
definita, qualificandosi in divinità vere e proprie, dotate di “personalità”,
o di qualità umane portate al massimo grado. Ecco che allora, nei loro
confronti, non valgono più tanto “esorcismi”, quanto preghiere,
non più riti umani spontanei, ma elaborati e organizzati, codificati, ma sempre
e comunque con lo stesso intento di lusingare la divinità per ottenerne i
favori. Magia e religione hanno in comune un altro fattore: quello segnato dalla
coscienza o consapevolezza della finitezza umana, della fragilità e della
limitazione delle forze umane rispetto a quelle del cosmo, della natura, di Dio,
che spinge l’uomo a tentare con ogni mezzo di superare questo dislivello. E’
quindi la coscienza di far parte di un tutto
e di condividerne, sia pur in maniera minima, alcuni elementi, che spinge
l’uomo a cercare di potenziare in sé queste forze, per poter agire e reagire
con esse su tutto. Questa è la base della magia simpatetica,
fondata appunto sul concetto che il simile è in grado di agire sul simile,
catturandone il consenso o vincendone l’ostilità. Spesso basta un minimo
appiglio (come un amuleto) per credere di avere il controllo dell’insieme
delle cose: è questo il principio secondo cui, essendo tutto nel suo insieme
connesso, anche una parte può avere effetto sul tutto. Spesso basta per questo
una parola, accompagnata magari da
gesti intesi ad affermare il proprio potere magico, per credere di poter agire
anche a distanza (dato che il tutto è connesso). Si tratta anche del
riconoscimento di qualcosa di non fisico
in grado di produrre effetti fisici, cioè di qualcosa di “spirituale”, di
invisibile in grado di agire sul visibile. Da ciò la credenza negli spiriti,
forze invisibili della natura: una credenza, in fondo, corrispondente al bisogno
di personalizzare l’occulto.
Certe tecniche magiche
tendono a combattere il mondo esterno, altre a conciliarselo, ma in ogni caso si
cerca di padroneggiarlo. La magia può quindi avere un risvolto positivo oppure
negativo, ma sempre nel presupposto di dover trattare con spiriti.
L’evocazione di questi spiriti rappresenta il lato saliente della magia e la
vera dimostrazione della forza del mago, da cui dipende il suo apprezzamento
sociale: per questo è insieme venerato e temuto.
Per quanto riguarda il
rapporto tra la mentalità magica primitiva e la scienza, si può sottolineare
come entrambe muovano da una ricerca di cause concepite come immanenti alla
natura (anziché trascendenti come è per la religione), sforzandosi di
ricondurle a un principio (concepito come una specie di “spirito
universale”). Lo scopo della magia è quello di conquistare un mondo dal quale
ci si sente vinti. Questo sforzo di
conquista è lo stesso che anima la scienza. La magia convive con la scienza
prima ancora di avere a che fare con la religione, avvalendosi di tecniche (anche se molto spesso inadatte o di scarso valore
scientifico) per ottenere certi risultati.
Più problematico e
complesso è il suo rapporto con la religione. Per quanto impersonali, le forze
con cui la magia è, o crede di essere, in rapporto tendono a personalizzarsi,
a configurarsi in sembianze quasi umane, tanto da venire designate, in tempi più
avanzati, addirittura con nomi propri. Le forze naturali divengono esseri
soprannaturali, qualificandosi in modo ormai del tutto trascendente come
“dei”. Questo corrisponde a un processo di idealizzazione e di
spiritualizzazione, di cui la magia, con altre forme primitive di pensiero, si
dimostra incapace.
ORIGINE
DEL SENSO MAGICO
La magia si suppone
diffusa ovunque e presso tutti gli uomini fin dalla preistoria: sarebbe inutile
decretarne una sola origine storica o geografica. La magia corrisponde alle
prime esigenze di far fronte alla natura, a quel cumulo di forze incombenti e
spesso minacciose che circondano l’uomo dalla sua apparizione sulla Terra.
Lo testimonia la frequenza di immagini “magiche” disegnate e impresse
un po’ ovunque sulle pareti delle grotte preistoriche, e in certi rituali
funebri di cui si conserva traccia in depositi ancora più antichi. Queste
suggestioni magiche appartengono per lo più al tipo della magia simpatetica,
intesa a produrre effetti per mezzo di immagini o simboli, anziché di atti
concreti. Il seppellimento ordinato dei defunti, addirittura con riti funerari,
sembra aver avuto lo stesso scopo: quello di produrre certi effetti tesi più
che a proteggere il morto, ad allontanare forze negative capaci di circolare tra
i vivi.
Il problema della
ricostruzione della mentalità dell’uomo primitivo consiste nel fatto che non
bastano i ritrovamenti e gli indizi provenienti direttamente dalla preistoria
attraverso gli scavi. Ma ciò che non è possibile storicamente, è possibile
(almeno entro certi limiti) analogicamente,
cioè per induzione, dall’osservazione di usi e costumi di popolazioni tuttora
viventi, che conservano un certo modo di pensare considerato primitivo (ma non
per questo inferiore a quello di chi studia questi popoli!). Si tratta allora di
considerare quelle comunità che ancora vivono al di fuori del nostro ambito
culturale, cioè che vivono in un loro
mondo in cui il rapporto con la natura non si è mai interrotto, ma continua a
fluire incessantemente.
Un errore da evitare
durante questi studi è quello di considerare “panteistico” o anche
“animistico” il pensiero magico primitivo, quasi come se esso fosse rivolto
separatamente a una venerazione del tutto o delle semplici forze che lo animano,
quando invece queste due realtà vanno assunte nel loro insieme. Altrettanto
inadeguato appare il termine “mitico” riferito al pensiero primitivo, poiché
l’elaborazione del mito (che va di pari passo con quella della religione)
appartiene a una fase più avanzata della mentalità umana. Il mito infatti
richiede una buona capacità logica di elaborazione dei dati che non sembra
appartenere alla mentalità primitiva: si può parlare comunque di favole
significative, trasmesse da una generazione all’altra.
Il senso magico deve
essere nato nell’uomo nel momento in cui assunse un comportamento autonomo rispetto alla natura, tale da interrompere la
dipendenza istintiva da essa, o meglio da non dipenderne completamente: cioè
quando si ottenne una “vittoria” della razionalità sull’istinto. Questa
vittoria può farsi corrispondere a una certa intuizione della totalità, non di una totalità generica, ma
specifica, all’interno della quale, per reciproca attrazione o “simpatia”
(syn- pathos), una cosa è vista trasformarsi di continuo in un’altra, una
forza confluire nell’altra, le parti scambiarsi certe proprietà fra loro e
col tutto (in quanto col tutto sempre collegate), la trascendenza convertirsi
con l’immanenza, l’individuo col clan, ecc. Sono questi i caratteri che si
ritrovano in tutte le religioni tradizionali d’Africa. Dunque l’uomo
primitivo ha del soprannaturale il concetto di qualcosa che non oltrepassa la
natura ma che vi sta dentro e la fa agire. In fondo anche il soprannaturale (o
spirito vitale) è del tutto naturale: l’intuizione e il sentimento che vi
corrisponde è infatti quello del tutto onnipresente
nelle cose.
L’uomo primitivo ignora
il concetto di “persona” come nozione distinta dalla semplice individualità.
La “persona” è per la prima volta qualificata in base alle sue facoltà in
ambito egiziano: l’intelligenza e la volontà costituiscono lo spirito. Nelle società primordiali l’individuo vale solo in
quanto membro di un gruppo (clan), di una totalità organica socialmente
organizzata. Egli è la cellula di un gruppo e le fasi della sua vita hanno
valore non in quanto riferibili alla persona, ma al clan. Allo stesso modo il
termine “spirito” per l’uomo primitivo indica gli spiriti della natura,
forze invisibili in grado di produrre certi effetti visibili. Queste forze sono
insite in oggetti, viventi o meno: animali, piante, acqua, terra, fuoco. Sono
forze impersonali, che devono la loro individualità alle cose in cui sono
presenti. Con simili entità, destituite di ogni personalità, non è possibile
alcun colloquio, ma vale solo contrapporre forza a forza, come è appunto
l’intento della magia. Non si può allora ancora parlare di una vera coscienza
religiosa, se per religione si intende l’avere a che fare con entità
personali.
Secondo J. G. Frazer (autore de “Il
ramo d’oro”), la magia precede la religione. Quest’ultima infatti richiede
maggior riflessione ed elaborazione di concetti astratti, atteggiandosi a poco a
poco anche a filosofia, mentre la magia rimane legata a una fase istintiva. Il
passaggio alla religione è collegato alla scoperta del concetto di
“personalità”. Le forze oscure che il mago crede di poter dominare non
hanno nome, si presentano in forma anonima e spersonalizzata alla stessa stregua
della forza vitale che pervade tutte
le cose e la quotidianità umana, vivificandole. In questo trapasso alla fase
religiosa ha grande importanza la trasformazione del concetto di spirito
vitale in quello di anima. Nella
magia questo concetto sembra appartenere a tutti gli esseri viventi, in quanto
partecipi dello spirito vitale e animati da esso. Nella religione invece
acquista una prerogativa antropologica, qualificando “in senso nobile” solo
l’uomo e la divinità.
IL MITO,
TRA MAGIA E RELIGIONE
A un certo punto
dell’evoluzione culturale umana si assiste a un fatto molto importante: la
nascita del mito destinato ad accreditare certe credenze magiche ereditate dai
tempi preistorici, convogliandole verso l’espressione di una spiritualità più
matura, o a crearne di nuove, includenti una vera moralità. I miti di Osiride e
quello di Adone, per esempio, erano in origine legati ai culti agrari intesi ad
assicurare la fertilità, ma in seguito furono elevati a un più alto
significato spirituale, come quello del perpetuarsi della vita dopo la morte, o
ad alimentare la credenza nella resurrezione. Specialmente in certi miti (come
quelli agrari) le divinità non sembrano in origine rivestire una vera
personalità, tanto che i loro attributi spesso si confondono con quelli degli
elementi che rappresentano (il grano per Osiride, il vino per Dioniso, la
selvaggina per Adone, ecc). In altri casi la loro individualità rimane
addirittura tuttora ancorata all’elemento naturale che l’ha suggerita, come
accade per gli spiriti arborei, le ninfe delle acque, i fauni dei boschi. In
questo caso non si parla di veri e propri miti, ma di favole o leggende. Con il
sorgere della religione il mito si amplia, si articola razionalmente, si fa
insieme più dettagliato e più astratto, prestandosi a incarnare ed esprimere
una vera moralità. Il mito si distingue dalla semplice favola o leggenda perché
non solo racconta, ma insegna; non si svolge semplicemente sul piano della
quotidianità, ma intende valere oltre che per il passato anche per il futuro.
La sua riflessione non è più pragmatica, ma assume carattere speculativo ed
etico. Il mito insomma prende sempre più le distanze dagli elementi naturali,
che pure possono averlo suggerito, cercando di inquadrarli in una visione più
ampia e umana. Anche dopo il suo sorgere, il mito non perde i suoi contatti con
la magia: spesso i miti si ricollegano a sacrifici (reali o simbolici) che hanno
lo scopo, più che di ingraziarsi la divinità, di farla servire ai propri fini,
come nel caso della magia.
CONCLUSIONE
La magia, senza potersi
dire una religione (da “re-ligare”, il che presuppone elementi distinti e
non ancora confusi come nell’accezione primitiva di sacro), prepara la strada
alla religione, cioè a un’accezione distinta della nozione di divinità in
senso trascendente: ben diversa cioè dalla natura, anche se a essa comunque
collegata. La magia infatti ha a che fare non con personalità divine vere e
proprie, ma con spiriti, geni, entità anonime sempre caratterizzate da una
grande mobilità, sempre pronte a dissolversi nell’elemento che rappresentano,
e di cui sono costituiti. La stessa idea di “spirito” non ha nulla che
evochi qualcosa di permanente o costante (come è invece per il concetto di
“anima”), o di separato dalla materia, ma vive con quest’ultima in uno
stretto rapporto di fusione; oppure è concepito come un fluido
vitale che scorre incessantemente in tutte le cose.
2.
Le
religioni tradizionali d’Africa
(saggio
di Romeo Fabbri, per conto della Campagna Chiama
l’Africa)
Ci sono comunque tre
principi di fondo comuni alle religioni tradizionali dei vari popoli africani:
- Monoteismo. Per molto tempo gli studiosi hanno pensato che le
religioni africane fossero politeiste, tratti in inganno dalla moltitudine di
nomi, che non rimandano a varie divinità, ma a diversi attributi-aspetti
dell’unico Essere Supremo. Le religioni tradizionali presentano una concezione
altissima e pura dell’Essere Supremo, che non ha prediletti e nemici, e non è
nemmeno il Dio distante/scostante della religione greca. Le religioni africane
hanno saputo coniugare lontananza e vicinanza, assoluta trascendenza e assoluta
presenza.
- Forza vitale. I popoli africani leggono l’intera realtà in
termini di forza vitale: conservazione, accrescimento, diminuzione,
ristabilimento della forza vitale. La relazione che intercorre fra il mondo
visibile e quello invisibile è una relazione di flussi o di bloccaggi di
energie vitali. L’energia vitale cosmica fluisce dall’Essere Supremo
continuamente, in modo diretto o indiretto attraverso gli spiriti subalterni,
gli antenati, i capitribù, gli eroi civilizzatori. E’ bene tutto ciò che
propizia la fecondità, è male tutto ciò che la ostacola. Riti e culti sono
finalizzati a sviluppare la forza vitale e a bloccare le forze che la ostacolano
o indeboliscono.
- Armonia. I popoli africani pongono sopra ogni iniziativa e ogni
sforzo una visione armonica del mondo, e la realizzazione di relazioni armoniche
a tutti i livelli: individuale, familiare, di villaggio, di tribù; relazioni
armoniche con il mondo vegetale e animale, e con il mondo invisibile.
HABITAT E
RELIGIONE
Un aspetto che colpisce in
modo particolare delle religioni tradizionali africane è lo stretto rapporto
esistente fra habitat, struttura sociale ed esperienza religiosa. I popoli
dediti alla caccia e raccolta (pigmei, boscimani, ottentotti) sottolineano la
relazione fra gli uomini da un lato, e animali selvatici e piante dall’altro.
I popoli dediti alla pastorizia (tutsi, masai) pongono al centro della loro
concezione religiosa gli animali domestici. I popoli delle grandi foreste (fang,
bete) tendono a vedere l’Essere Supremo in relazione alla vegetazione
rigogliosa e alle forze della natura. I popoli della savana (bambara) dipendono
dalle colture e dal ritmo delle stagioni, e privilegiano il suolo e i campi. I
popoli dediti alla pesca (bozo) e gli agricoltori della regione del sahel (dogon)
pongono al centro della loro vita il problema dell’acqua. I popoli dei grandi
imperi (benin, ashanti, yoruba) celebrano il ruolo di personaggi legati alla
storia dell’impero, costruendo attorno a queste figure miti, riti e culti
assicurati da una casta di sacerdoti.
L’ESSERE
SUPREMO: NOMI, NATURA E RELAZIONI CON IL MONDO UMANO
Per tutti i popoli
africani l’Essere Supremo è assolutamente unico, è la fonte di tutta la vita
esistente nell’universo, vive lontano dagli uomini ma è al tempo stesso
vicino a loro. Essi gli rendono raramente un culto pubblico ufficiale, più
spesso si tratta di un culto privato. L’Essere Supremo non può essere
rappresentato: in Africa si trovano moltissime statuette-feticcio che ritraggono
uomini, animali e spiriti, ma nessuna raffigura l’Essere Supremo. Può solo
essere oggetto di discorso, e i popoli africani gli hanno riservato una miriade
di nomi, per tentare di coglierne il volto e determinarne la natura. Il termine
Zambe, per esempio, ricopre con leggere variazioni (Zamba, Nyame, Nzambi,
Anzambe) un’area geografica che si estende dalla Costa d’Avorio al Botswana.
I pigmei chiamano l’Essere Supremo Epilipilia (signore della caccia), i
boscimani Raggen (padre), gli ottentotti Tsuri-Goab (creatore del mondo
visibile). Altri nomi diffusi sono: Mungu-Midunga (colui che sta in cielo),
Yankompon (il grande amico) degli ashanti, che considerano il cielo il suo volto
splendente, Aforun (colui che è per se stesso) degli yoruba, e Ngai (la
pioggia) dei masai.
Gli attributi che tutti i
popoli africani riconoscono all’Essere Supremo sono:
- E’ in sé e per sé:
“ha preceduto la creazione degli uomini, non ha padre ne’ madre” (mbien),
“colui che si è fatto esistere da solo” (zulu).
- E’ uno: anche quando
si usano diversi nomi contemporaneamente, il verbo si usa al singolare.
- E’ eterno.
- Onnipresente.
- Onnisciente: “il
grande occhio” (Uganda), “Nzambi non dorme, ti vede” (mbien).
- Onnipotente: “se
Nzambi ci chiama, chi potrà resistere?” (kongo).
- Trascendente: “colui
che abita al di sopra, nessuno è al di sopra di lui” (kongo).
- Creatore.
- Provvidente: “se
l’Essere Supremo morisse, il mondo crollerebbe” (bambuti)
- Buono, saggio e giusto.
Tutti i popoli africani
vedono l’Essere Supremo come lontano, assente dal mondo sensibile e al tempo
stesso presente nella vita quotidiana e provvidente nei confronti dell’uomo.
Si tengono saldamente insieme due affermazioni opposte: è trascendente,
infinitamente lontano e inaccessibile; è immanente, infinitamente vicino a ogni
uomo. Molti miti raccontano il breve soggiorno dell’Essere supremo nel mondo
dopo la creazione, il suo allontanamento e i tentativi degli uomini di dare la
scalata al cielo (pigmei, giziga del Camerun settentrionale, ila dello Zambia,
chagga del Kenya). Per comprendere l’apparente paradosso del Dio lontano e
vicino, sono utili anche i proverbi, altra produzione spontanea e antichissima
dei popoli: “Nyamuzinda non dimentica i suoi” (bashi); “non esiste una
valle così solitaria che l’Essere Supremo non veda” (Madagascar); “il
sole non dimentica nessun villaggio” (Congo). L’Essere Supremo insomma è
lontano dal mondo materiale ma nel contempo è vicinissimo all’uomo, sua
creatura.
I
MEDIATORI
Fra l’uomo e il mondo
invisibile esiste una fitta e intricata rete di relazioni positive e negative,
un complesso sistema di intersezioni, una sorta di scala i cui gradini inferiori
stanno nell’ambito umano e quelli superiori raggiungono l’ambito del
sovrasensibile e del trascendente (non l’Essere Supremo in sé). I due ordini
di gradini si congiungono al centro, dove si trovano, sul versante umano,
persone che svolgono un ruolo privilegiato, e sul versante divino, gli spiriti.
Questa dialettica è perfettamente in linea con la prassi umana di servirsi di mediatori,
quando si vogliono avvicinare persone superiori al proprio rango.
- Mediatori provenienti
dall’alto: sono spiriti delegati
dall’Essere Supremo a compiere determinate funzioni nel mondo e presso gli
uomini. Hanno natura antropomorfica e incarnano forze dinamiche in continua
oscillazione, per cui devono essere trattenute con offerte.
- Mediatori provenienti
dal basso: sono tutte le persone che svolgono
un ruolo privilegiato nelle relazioni tra il singolo o la comunità e la realtà
trascendente. Capofamiglia: mediatore
a livello degli individui e delle famiglie. Anziano: nella saggezza africana occupa un posto importantissimo,
perché è di più (non si nasce persone complete, ma lo si diventa con gli
anni), sarà di più (è temporalmente più vicino allo stadio di antenato, per
cui intrattiene legami più stretti coi defunti), sa di più (è come una
biblioteca per la comunità), può di più (il sapere è potere). Capo della terra e capo del
clan: spesso due capi distinti, uno ha potere sulla terra come fonte di vita
e ricettacolo degli antenati, e interviene nei riti agrari, l’altro ha potere
politico sul territorio e amministra la giustizia. Vasaia e fabbro: possono maneggiare senza pericolo la sostanza
terrestre e hanno il compito di modellare gli strumenti per il culto degli
antenati. Il fabbro è l’intermediario per eccellenza, poiché domina il fuoco
e la terra, quando batte sull’incudine sprigiona forze cosmiche che poi
orienta, è rispettato e temuto allo stesso tempo. Sacerdote:
possiede le parole sacre e rappresenta il popolo di fronte al mondo
trascendente. Re: ha origine
semi-divina, attraverso lui la forza vitale di Dio giunge al popolo. Indovino:
iniziato a un codice che gli consente di decrittare i messaggi che provengono
dal mondo degli spiriti e degli antenati, scopre le cause degli avvenimenti e può
interpretare i sogni. Guaritore: usa
le piante medicinali, spesso è uno specialista che guarisce solo certe
malattie, comunica intensamente con il malato e opera su un piano psicologico e
religioso. Mago: cerca di captare e
dominare certe forze, a volte ha un ruolo positivo, ma altre volte negativo,
quando cerca di far del male a qualcuno.
- Due categorie
privilegiate di mediatori dal basso:
1) Gli antenati: conoscono meglio di chiunque la condizione e i bisogni
umani. Scrive Birago Diop: “Coloro che sono morti non sono mai partiti / Sono
nell’ombra che si schiarisce / e nell’ombra che si ispessisce. / I morti non
sono sottoterra: / sono nell’albero che freme / sono nel legno che geme / sono
nell’acqua che scorre / sono nell’acqua che dorme / sono nella capanna, sono
nella folla: / i morti non sono morti”. Gli antenati (chiamati morti-vivi)
sono viventi di un genere particolare. La morte non ne ha alterato la personalità,
solo il loro modo di vita è cambiato. Continuano a fare parte della comunità
dei vivi. Alla base di questa concezione comune a tutta l’Africa sta il
primato assoluto accordato alla vita: la vita è il solo bene reale, la forza
stessa di Dio. E’ impensabile quindi che la vita possa cessare, che possa
essere vinta dalla morte. Gli antenati sono le vere guide direttive della società.
Sono fatti oggetto di un culto premuroso e costante, con offerte di cibo e
rispetto da parte di tutti i membri del clan. Gli antenati assicurano la
continuità del gruppo e quindi la fecondità, e conservano l’armonia tra i
vivi e i defunti.
2) Gli eroi civilizzatori: trasmettono e accrescono la vita del singolo o
del clan sul piano storico, culturale, spirituale. Sono ad esempio il re saggio,
il guerriero valoroso, l’anziano riflessivo, l’inventore di una particolare
tecnica. Non si tratta di una paternità fisica, ma una paternità che accresce
la vita illuminandola, potenziandola.
LE FORZE
NEGATIVE
Accanto agli intermediari
positivi esistono anche delle forze del male. Può trattarsi di forze anonime,
impersonali, o di persone che fanno del male, come per esempio i ritornanti
(persone morte malamente, provando risentimento, che tornano per vendicarsi una
volta divenuti potenti), gli aberranti (viventi che cercano di fare del male
agli altri: omosessuali, uomini-leopardo, associazioni segrete di persone
malvagie), gli stregoni (mentre la magia è una tecnica, la stregoneria è uno
stato di vita, spesso inconscio. Nello stregone abita un’entità malefica che
sottrae energia alle persone agendo a distanza. Lo stregone non usa strumenti e
può essere smascherato dall’indovino).
IL CULTO
Manca quasi completamente
il culto pubblico e ufficiale reso all’Essere Supremo: egli deve essere
disturbato il meno possibile, solo in situazioni estremamente gravi (persistente
siccità, epidemie, guerre), o in relazione con i grandi momenti della vita
(nascita, iniziazione, morte). D’altra parte, l’uomo africano è convinto
che Egli abbia affidato ogni cosa a entità subordinate. Il sacrificio fatto
all’Essere Supremo mira alla salvezza del popolo. Si offrono in genere cose
trascurabili, ma di alto valore simbolico, oggetti che simboleggiano la vita
(uova, piante da frutto, colore bianco).
Il culto compare spesso
nell’ambito della vita privata; le sue maggiori espressioni sono la preghiera
e l’offerta. La preghiera ha una tipologia molto varia: ci sono preghiere
abituali e occasionali, espresse in formule, spesso brevi esclamazioni, oppure
preghiere consistenti in semplici gesti. L’offerta ha lo scopo di rigenerare
la forza vitale del singolo o del gruppo. In genere viene fatta agli antenati e
agli spiriti, la cui forza vitale non è costante perché non possiedono vita in
proprio, come l’Essere Supremo, per cui donandola la perdono, si depotenziano,
e hanno bisogno di rigenerarla. L’antenato possiede l’immortalità finché
qualcuno si ricorda di lui; l’offerta serve a mantenerlo in vita, a vantaggio
dei sopravvissuti.
CONCLUSIONE
L’uomo africano non è
interessato a dominare, ma a comprendere, a farsi del mondo che lo circonda
un’immagine in grado di guidarlo nelle sue scelte, e di rassicurarlo nei suoi
smarrimenti. Si interroga continuamente sul perché di ciò che accade: una
malattia, una siccità, un insuccesso nella caccia. Cerca personalmente o
insieme al proprio gruppo una risposta in grado di rassicurarlo e di persuaderlo
che tutto è in ordine, che tutto funziona a dovere. Quando, nonostante tutto,
non si riesce a trovare una risposta, resta sempre come via d’uscita
all’assurdo, al non-senso, l’Essere Supremo. La cultura africana è
antropocentrica, non teocentrica. L’assenza di Dio, il suo “esilio”
volontario, diventa la conditio sine qua
non della libertà umana. Solo così
l’uomo può passare dalla condizione di assistito, incompleto e
irresponsabile, alla condizione di persona responsabile di se stessa e del
mondo. La religione tradizionale africana proietta l’uomo più verso il
passato che non verso il futuro. La conservazione e l’accrescimento della
forza vitale richiedono che l’individuo, il clan, la tribù, restino
aggrappati alle loro origini mitiche, rispettando le tradizioni sacrali e
sociali stabilite dagli antenati.
• Da quanto esposto, e
da altre letture qui non sintetizzate perché molto simili ai due saggi
proposti, si può affermare che le religioni tradizionali d’Africa abbiano in
un certo modo conservato una mentalità di fondo che le collega a una visione
molto antica nell’uomo.
La religione africana si
è ormai da tempo slegata dal puro ambito magico (nell’accezione discussa da
Masi nel primo saggio), ma trattiene in sé una visione del mondo che si può
definire molto arcaica, remota, specialmente per quanto riguarda il rapporto tra
il mondo materiale e quello invisibile, tra l’uomo e l’unica Entità
Suprema, e poi il concetto del flusso
vitale che scorre incessantemente e ha bisogno di essere sempre
rivitalizzato, il rispetto e il culto degli antenati come ancora facenti parte
della comunità, l’importanza del mito e della tradizione.
Questa visione, questo sentire
religioso, sembra porsi “a metà strada” fra il semplice pensiero magico
primordiale e primitivo, e l’elaborazione teoretica e sistematica delle grandi
religioni (cristianesimo, islamismo, ebraismo, induismo): l’uomo africano ha
raggiunto la piena consapevolezza del
dato divino, sa benissimo con quale tipo di mondo invisibile e trascendente ha a
che fare, ma non ha bisogno della
mediazione formale di una dottrina, di un dogma, di un sistema anche
filosofico ordinato e magari scritto.
La funzione dell’anziano
consiste anche in questo: trasmettere oralmente la religione tradizionale e il
rispetto delle entità superiori (antenati e spiriti), e i loro profondi
significati. Nella cultura africana i bambini e i vecchi sono le persone viventi
più importanti: attraverso i bambini passa e si rafforza il flusso vitale che
rinsalda la comunità, attraverso i vecchi la tradizione non morirà mai.
BIBLIOGRAFIA
1)
G. Masi, Lo spirito magico. Saggi sul
pensiero primitivo. CLUEB Bologna, 1999.
Contributi:
J. G. Frazer, The golden bough.
Londra, 1911-15 (tr. it. Il ramo d’oro. Torino, 1950)
R. Cantoni, Il pensiero dei
primitivi. Milano, 1963.
E. B. Tylor, Primitive culture.
Londra, 1871
R. Otto, Il Sacro,
tr. it. 1926.
2)
R. Fabbri, Le religioni tradizionali
d’Africa. (per conto della Campagna “Chiama l’Africa”).
Contributi:
J. Mbiti, Oltre la magia. Religioni e
culture del mondo africano. SEI, Torino, 1992.
Padre Maurilio Montefiori, I
Burunge. Editrice Cesare Ferrari.
Padre P. Calloni, Tam tam.
Editrice Cammino.
3.
Appendice:
alcuni miti e racconti africani
Elima (la forza
vitale attiva e personale) creò
gli stagni, i corsi d’acqua e le foreste, e vi fece comparire gli animali che
le popolano attualmente. Raccolse argilla umida e fece due statue, una di un
uomo e una di una donna. Vi soffiò la vita e ordinò: “Parlate!”. Poi
cominciò l’educazione dei primi antenati. Insegnò loro i nomi delle bestie e
delle piante, mostrò come fabbricare una capanna e accendere un fuoco, come
cercare frutti e tuberi commestibili. Regalò loro un arco e delle frecce, e una
zucca come contenitore per l’acqua. Gli antenati non videro Elima, lo
sentirono soltanto. Egli raccomandò loro di fare il bene e di evitare il male:
il furto, la menzogna, la frode, l’omicidio, l’adulterio, la calunnia, la
disobbedienza a genitori e capi-clan. Quando li lasciò, i primi uomini accesero
il fuoco e partirono per la caccia.
·
Si
potrebbero notare moltissimi punti importanti in questo racconto (la divinità
vista come forza e già personalizzata, l’uso del “soffio di vita”,
l’insegnamento di Dio, l’impossibilità di vederlo, i comandamenti), ma qui
è interessante rilevare che secondo questo popolo fu Dio a insegnare agli
uomini tutto ciò di cui avevano bisogno, mentre per altri popoli (pigmei) Dio
se ne andò dal mondo prima che l’uomo fosse autonomo da Lui, costringendolo
in un certo senso a usare l’ingegno per sopravvivere: non è forse proprio
quello che è avvenuto nella lunga storia dell’evoluzione umana ?
All’inizio del tempo Dio
(cioè l’Essere Supremo) fece un certo numero di uomini e donne. Egli viveva
fra loro, procurando loro tutto ciò di cui avevano bisogno: la legna,
l’acqua, gli animali, ecc. Una donna era incaricata di portargli acqua e
legna, ma non doveva mai alzare gli occhi per vederlo. Un triste giorno, vinta
dalla curiosità, mentre deponeva la brocca al di là della porta semiaperta,
gettò un timido sguardo. Nella penombra vide il braccio di Dio coperto di
braccialetti, provò una gran gioia, ma non durò molto, perché Dio aveva
notato la sua indiscrezione. Molto irritato da questa trasgressione umana, se ne
andò e abbandonò tutti alla loro sorte. Tutto ciò che egli aveva donato un
tempo agli uomini, cominciò a mancare. Alcuni di loro, con le loro mogli, se ne
andarono nella foresta. Ebbero l’idea di curvare un legno verde e di legare le
estremità con una liana, inventando così l’arco. Le donne impararono a
intrecciare rami a forma di cupola e rivestirli di foglie, inventando così la
capanna. Con la loro ingegnosità provvidero ai propri bisogni e seppero
approfittare al massimo delle risorse della foresta. Questa è l’origine della
razza dei pigmei.
·
Dio
ha creato per l’uomo la natura e le sue risorse, ma è l’uomo che ha dovuto
usare il suo ingegno per costruire utensili e quindi inventare la tecnologia.
Nota interessante: la donna fu “vinta dalla curiosità”. Il divino, il
trascendente, il “totalmente altro” suscita insieme fascino, perché lo si
vorrebbe poter conoscere, e timore (a volte persino un vero terrore
reverenziale), perché la sua potenza oltrepassa qualsiasi visione e
immaginazione umana.
MITO
GIZIGA (Camerun settentrionale)
Un tempo il cielo era
vicino alla terra. Bumbulvun viveva in mezzo agli uomini. Era anzi talmente
vicino che essi potevano spostarsi solo con la schiena curva. Ma in cambio non
dovevano preoccuparsi del loro sostentamento: bastava allungare la mano,
strappare dei pezzi di cielo e mangiarli. Un giorno la giovane figlia del capo,
che aveva un brutto carattere e faceva sempre il contrario degli altri, invece
di prendere pezzi di cielo, cominciò a guardare per terra e a raccogliere i
grani che trovava. Si fece un pestello e un mortaio per schiacciare i grani. Così
inginocchiata, ogni volta che alzava il pestello, questo colpiva il cielo e Dio.
Disturbata nel suo lavoro, la giovane disse al cielo: “Bumbulvun, non puoi
allontanarti un po’?”. Il cielo si allontanò e la giovane poté alzarsi in
piedi. Continuò il suo lavoro e man mano che schiacciava grani alzava il
pestello sempre un po’ più in alto. Implorava il cielo, ed esso si
allontanava ancora un po’. Allora cominciò a lanciare il pestello in aria.
Alla terza implorazione il cielo, indignato, se ne andò lontano, là dove si
trova ora. Da allora gli uomini camminano eretti. Non mangiano più pezzi di
cielo, ma miglio. Ma Bumbulvun non si mostrò più agli uomini come faceva un
tempo, quando tutte le sere veniva a risolvere le loro contese; ora gli uomini
sono rimasti soli con le loro contese: è la guerra!
Una donna, che viveva
felice fra i suoi parenti, un giorno perse il padre, poi, poco dopo, la madre.
Non era passato un mese che le morì il marito e poi, uno dopo l’altro, tutti
i figli. Si ritrovò sola, prostrata dal dolore davanti a quelle tombe chiuse e
mute. Allora, al limite della sopportazione, partì alla ricerca di Leza per
chiedergliene conto. Attraversando una fitta foresta ebbe un’idea: “Costruirò
una torre così alta da permettermi di salire fino a Leza!”. Cominciò ad
abbattere alberi e costruire una torre enorme. Ci volle molto tempo: le stagioni
passavano e i tronchi posti in basso imputridivano, e il tutto crollò proprio
nel momento in cui stava raggiungendo il cielo. Allora riprese il viaggio e andò
verso l’orizzonte, alla ricerca del punto in cui la terra finisce. Incontrò
molti villaggi e sentì sempre la stessa domanda: “Donna, dove vai, e perché?”
– “Vado a cercare Dio, per chiedergli conto di tutte le mie sventure: ho
avuto un padre, ed è morto; ho avuto una madre ed è morta; ho avuto un marito
ed è morto; ho avuto dei figli e sono morti!”. Ogni volta la gente scuoteva
la testa: “E cosa c’è di straordinario in tutto questo? Tutti noi soffriamo
degli stessi mali”. La donna infine comprese che ciò che considerava una
cattiveria di Dio a suo riguardo, altro non era che la sorte di tutta l’umanità.
Così si rassegnò a seguire la sorte normale senza rivoltarsi.
·
Elementi
comuni a molte altre religioni sono per esempio: il desiderio dell’uomo di
capire il perché di avvenimenti tragici come la morte, la convinzione di essere
l’unica persona perseguitata dal dolore quando invece esso è condizione
comune a tutti gli uomini, il tentativo di dare la scalata al cielo per
raggiungere Dio e l’inevitabile fallimento di questa ricerca (Dio è
irraggiungibile). La saggezza di fondo di questo racconto indica chiaramente che
esso costituisce un vero e proprio mito (nell’accezione discussa da Masi nel
primo saggio): ne sono prova l’elaborazione del dato divino, l’insegnamento
morale di fondo, l’universalità del messaggio.
Un uomo che aveva perso
tutti i figli concepì in cuor suo un gran risentimento contro Dio, così si
fece costruire un arco capace di raggiungere il cielo e le migliori frecce per
uccidere Dio. Poi si mise in cammino verso il sorgere del sole. Una volta giunto
là, attese il sorgere del sole. Si sentì il rumore di una gran folla e molte
voci: “Aprite le porte! Lasciate passare il Re!”. L’uomo vide una
moltitudine di persone luminose, ebbe paura e si nascose. Il corteo passò e al
centro c’era “Colui che brilla”. D’un tratto il corteo si fermò e
quelle persone sentirono un odore spaventoso, che faceva pensare alla presenza
di un abitante della terra. Alla fine scoprirono l’uomo e lo condussero da
Dio. Questi gli chiese: “Che cosa vuoi?”, e l’uomo rispose: “Il dolore
mi ha spinto a fuggire lontano dalla mia capanna”. “Ma perché quest’arco
e queste frecce?” – “Oh, forse pensavo di andare a caccia…” – “Non
volevi forse uccidermi? Ebbene, fallo!”. L’uomo esitò e disse: “E’ a
causa dei figli che tu mi hai sottratto”. Dio rispose: “Se vuoi i tuoi
figli, puoi prenderli. Guarda, sono lì dietro di te”. L’uomo si voltò e li
vide; erano così radiosi e brillanti che riuscì a malapena a riconoscerli.
Allora disse a Dio: “No! Tienili tu. Presso di te stanno molto meglio!”.
·
Simile
nella forma e nel contenuto al mito precedente, questo mito chagga esprime con
estrema delicatezza e semplicità il senso tutto umano di capire il perché
degli eventi, e il bisogno eterno di credere in una vita post-mortem più bella
e piena di quella terrena (anche qui siamo già in un pensiero religioso
compiuto, poiché nel pensiero magico primitivo sembra non esistere la
distinzione fra queste “due vite”, in uno stato confuso di ritorni e
mescolamenti delle entità nel mondo). Da notare la “violenza”,
l’immediatezza delle prime righe: quando
non sappiamo con chi prendercela, perché non vediamo la causa di un evento
tragico e inspiegabile, ricorriamo a Dio addossandogli una colpa inesistente (la
morte è un fatto naturale, anche se per l’uomo di difficilissima
comprensione, senza “l’aiuto” offerto dall’esistenza di una sfera
divina). L’uomo africano è pienamente conscio di questo aspetto, e così come
nelle religioni più “moderne” (in senso temporale), cerca di trovare
l’unica soluzione possibile nel mondo dell’invisibile e del “totalmente
altro” (altro nelle forme: i defunti non si presentano come persone normali;
altro nei contenuti: i defunti appaiono felici e in uno stato di “pienezza”,
portando al massimo grado la vita).