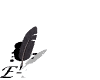TEMATICHE:
Due passi nell'Italia nascosta
Simbologia e Cultura Orientale
UTILITY:
Ricerca veloce titoli per argomento
SERVIZI:
|
Julia Carta, sa Majarza |
||
|
Storia della strega più famosa di Sardegna
(di Simone Petrelli) |
||
|
Con le sue 150 anime appena, Bidonì non è certo uno dei paesi più grandi della regione storica del Barigadu, né tantomeno della provincia oristanese. Per dirla tutta, è anzi uno dei comuni più piccoli di tutta la Sardegna. Ci si arriva dopo essersi lasciati alle spalle alberi di sughero, querce e tanta macchia mediterranea, superando un ponte sul fiume Tirso ed una serie di tornanti non propriamente notevoli che, gradualmente, conducono la strada fino a 260 metri di altitudine sul livello del mare. Dopo aver imboccato la strada provinciale che da Ghilarza porta a Tadasuni e, di qui, a Sorradile ed infine nel Mandrolisai, si riesce a scorgere un riflesso d’acqua. E’ il lago Omodeo, artificialmente nato dallo sbarramento delle acque del Tirso ed inaugurato nel 1924 alla presenza di Sua Maestà Re Vittorio Emanuele III quale lago artificiale più grande d’Europa grazie ai suoi 403milioni di metri cubi d'acqua di capacità complessiva. Adagiato sulla sponda meridionale dell’Omodeo riposa Bidonì. Un paesino con un paio di chiese (la prima delle quali appartiene all’unica parrocchia, S.Giovanni Battista, mentre l’altra sorge a ridosso del camposanto), ed un novenario campestre edificato nel lontano 1632.
Uno scorcio di Bidoni, in prov, di Oristano, in Sardegna Di recente, sulla sommità del limitrofo colle periferico di Onnariu sono stati rivenuti i resti di un tempio dedicato a Giove, da subito aggiuntosi alle attrattive archeologiche più canoniche dell’area, alcune domos de janas sparse tra le colline ed un nuraghe detto di Bentosu. Completano il quadro uno studio medico, una biblioteca, e perfino un sito web che ricorda l’esatta posizione – o probabilmente l’esistenza stessa - del paese a chi ancora non abbia avuto la ventura di visitarlo o di imbattervisi. Se si escludono alcune volenterose attività sociali e sportive (per lo più messe in piedi dalla locale parrocchia), una sagra annuale ed un paio di celebrazioni religiose, il tempo libero della popolazione se ne va tra le soste in piazza e quelle presso l’immancabile bar centrale. Si affacciano sempre più raramente ormai, i bidonesi, in via Monte 9, all’ingresso ristrutturato di quello che una volta era il municipio del paese. A distanza di un anno appena, non provoca loro più così tanta curiosità il convivere con S’Omo ‘e sa Majarza. La Casa della Maliarda, della strega, in vernacolo oristanese. Non poteva esistere titolo più azzeccato per un’esposizione permanente dedicata alla stregoneria, al diavolo e perfino agli innumerevoli esseri fantastici e fate che tante case - o domos - sembrano aver abitato nell’isola. Impressionanti riproduzioni di xilografie a tinte forti, realizzate tra il 1300 ed il 1500 ed impiegate qui per adornare le pareti, gli originali di molte delle quali ornano le pagine dell’arcinoto Malleus Maleficarum che tanto materiale donò agli scrupoli degli inquisitori. Racconti ed illustrazioni legati alle divinità infere di epoca romana.
Una xilografia dal Malleus Maleficarum (fonte: neptun8.ru) Teche contenenti amuleti di popolana memoria. Materiale da contus de foxili, racconti di focolare sulle favolose janas, sui folletti, sui diavoli e le streghe delle notti più selvagge di Sardegna. Visto tutto questo, si arriva presto al culmine del museo. Che non è sa Filonzana, la donna vestita di nero che, in un angolo, reca saldo tra le mani il fuso del destino alla stregua di una Moira greca o di una Norna bretone. Il pezzo forte di tutta l’esposizione è un latro. L’antro di una fattucchiera, per la precisione. Una ricostruzione, non orfana tra l’altro di una certa oculatezza di dettagli, riferita ad una storia esemplare. Una storia vera. La storia, soprattutto, di una strega. Julia Casu Masia Porcu, assurta agli onori delle cronache semplicemente come Julia Carta. 35enne, nata in un paese di pastori del sassarese, Mores. Forse la coga, la megera più famosa di Sardegna. Un personaggio liminare, a metà strada tra la demonizzazione di cui è stata oggetto secoli fa ed una non trascurabile rivalutazione postuma, compiuta in epoca più recente da storici e studiosi di folklore locale. E’ da lei che prende il nome il museo. La Casa della Strega, insomma, è la sua. Se ci si allontana da Bidonì e si inizia a risalire l’isola, dopo un’ora e 15 minuti circa di automobile si raggiunge la provincia di Sassari. In 90 chilometri esatti si arriva nelle colline del Meilogu, tra rilievi di origine vulcanica come la mesa del Monte Santu o il Monte Ruju. Qui sorge Siligo. Non è un percorso troppo lungo. Ma il tragitto è bastevole per dare una forma ed un contesto concreto alle pur suggestive ma evanescenti ricostruzioni leggendarie contenute nel Museo delle streghe perduto nell’oristanese. Siligo ha poco meno di 1000 abitanti, ed un’origine immensamente più antica di quella di Bidonì. Viene ad esempio citato, ricorrendo a denominazioni varie quali Siloque, Siloghe, Syloge, da San Nicola di Trullas e da San Michele di Salvenero nel testo dei loro condaghi, raccolte di atti riguardanti negozi giuridici e similari, risalenti al XIII secolo o, addirittura, ad un paio di secoli prima. A differenza di Bidonì, Siligo ha quattro chiese storiche. Un santuario nuragico. Un parco archeologico. Sul territorio di sua giurisdizione si trovano inoltre sei differenti aree ricolme di ruderi di edifici di culto. Più ventiquattro nuraghi in differente stato di conservazione. Un osservatorio astronomico in località Coas e, non ultimo, un planetario gestito dalla Società Astronomica Turritana di Sassari che si affaccia proprio su una delle piazze principali del paese, Piazza Maria Carta. Siligo vanta inoltre tra i suoi concittadini illustri un poeta ed un’attrice, uno scienziato ed una cantante, uno scrittore e perfino un doppiatore. Al paese sono legate le origini dell’attore Gianni Agus, per non parlare di quelle del politico, picconatore ed ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Soprattutto, per quel che ci riguarda, Siligo è la patria d’adozione di Julia Carta, la strega. Una donna processata dal tribunale dell'Inquisizione nell’autunno del 1596. Tornata a sottomettersi all’impietoso giudizio dei supremi purificatori nel 1606 come relapsa, cioè recidiva. Sopravvissuta per ben due volte alla spaventosa prossimità del rogo ecclesiastico ed all’inferno in terra di cui esso era primigenia espressione. Il 1492 è un annus mirabilis. Si apre con la caduta dell’ultima roccaforte moresca in Spagna, Granada, che segna ufficialmente la fine della Reconquista e la conseguente riunificazione del regno sotto l’egida di Ferdinando II d'Aragona ed Isabella di Castiglia. Nel mese di aprile, un’uricemia ereditaria presto degenerata in letale infezione pone fine ai giorni di Lorenzo il Magnifico, mentre questi viene vegliato da Michelangelo Buonarroti e dal frate domenicano Girolamo Savonarola, che si prodiga nel somministrare al magnate e princeps l’estrema unzione. Natura non produrrà mai più un simile uomo, commenterà Caterina Sforza, Signora di Forlì ed Imola. In luglio si spegne anche Innocenzo VIII, cui succede il 214esimo Papa della Chiesa di Roma, Alessandro VI. Tra agosto ed ottobre, si compie l’impresa di Colombo e del suo erroneo viaggio verso le Indie, che cambierà il corso della storia in modi che il navigatore genovese non immagina minimamente. Mentre un meteorite da 120 chilogrammi solca i cieli di Alsazia per schiantarsi con fragore al suolo, tramonta l’epoca medievale per far posto all’Evo Moderno. Entro il mese di luglio, gli ebrei vengono espulsi per regio decreto dal suolo di Spagna, fatta eccezione per coloro che accettino di convertirsi al cattolicesimo. Medesimo procedimento si applica, al 31 dicembre dello stesso anno, ai 100mila figli di Israele che risiedono in Sicilia. La guardia della Chiesa si fa insomma più serrata in tutte le provincie spagnole e nelle terre cattoliche, che in questo frangente storico coincidono quasi alla perfezione. La Sardegna non fa eccezione. E’ il 1492 quando il priore del convento della Santa Cruz di Segovia e confessore dei Re Cattolici, un domenicano di nome Tomas de Torquemada, elegge Sancho Marin. Con lui, si radica formalmente nel Regno di Sardegna il tribunale dell’Inquisizione, ufficialmente inaugurato in terra spagnola già 14 anni prima. La branca sarda opererà da Cagliari, ed a Marin non rimane che individuare una sede consona alle esigenze del venturo istituto di suprema purificazione.
Francisco Goya, Scena di inquisizione, 1812-1819, Accademia Reale delle Belle Arti di San Fernando (fonte: summagallicana.it)
Il luogo prescelto dal neonominato inquisitore è uno stabile da ristrutturare che si trova in località La Stellada, nella zona oggi inquadrata tra va Bacaredda, via dei Giudicati e viale Ciusa. Il singolare tribunale funziona fin troppo alla perfezione, con competenza esclusiva in materia di ortodossia della fede nella strenua lotta contro infiltrazioni giudaizzanti o islamiche, cui si va progressivamente aggiungendo anche l’opposizione, sempre più feroce, nei confronti degli eretici per eccellenza, i protestanti. Per più di settant’anni Cagliari fa da cornice agli oscuri offici del Santo Ufficio. E’ il 1563 quando si decide di cambiarne la sede. Frattanto, è mutato anche l’inquisitore. Presiede ora il giudizio padre Diego Calvo, che opta per la migliore allocazione offerta dal trecentesco castello aragonese di Sassari capace di ospitare, oltre alla sede più propria dei processi, anche la residenza dell’inquisitore stesso, le carceri e, inutile precisarlo, una sala di tortura con mura spesse, bastevolmente almeno da evitare eventuali, sgradite interferenze. Soprattutto, Sassari risulta una roccaforte strategicamente più importante, prossima come risulta essere nei confronti dei porti della Sardegna settentrionale, e dei conseguenti contagi ideologici, filosofici e massimamente religiosi che di qui potevano transitare. Calvo è implacabile. In appena tre anni semina il panico in tutta l’isola, giungendo ad organizzare una due giorni in cui vengono spiccate senza sosta feroci condanne contro 70 poenitentiati e, culmen dell’evento pubblico, ben 13 condanne al rogo purificatore. In un secolo e mezzo – tra il 1550 e la fine del 1600 - la Santa Inquisizione indaga ed accerta sul suolo sardo 165 casi di stregoneria e magia, additando un totale di 105 streghe e 60 stregoni. Da cifre simili ci si potrebbe forse attendere una carneficina sul campo. In realtà, i condannati non vengono praticamente mai consegnati nelle mani del potere secolare. Dunque, alle condanne non seguono pene capitali né roghi di sorta.
Il Castello Aragonese di Sassari, acquerello (fonte: blogosfere.it) Il tribunale sembra piuttosto avere manica larga. Pene e sanzioni vengono in sostanza erogate con una certa mitezza, e sempre più di frequente si ricorre a confisca dei beni, traduzioni moderate in carcere o esilio, temporaneo o perpetuo, dal paese di residenza. I processi più noti e documentati risultano tutti coronati dalle sconcertanti confessioni minuziosamente estorte dagli ecclesiastici, nelle quali misteriose valli dell’inferno si mescolano con boschi popolati da nugoli di adoratori del demonio, oscuri gentiluomini vestiti con abiti sgargianti o addirittura ricerche pilotate di favolosi tesori scomparsi. Caterina Curcas da Castel Aragonès, Angela Calvia da Sedini, Anna Collu da Oristano. Nomi e provenienze delle principali imputate di queste antiche istruttorie. Altrettante voci di una lista interminabile, lunga più di duecento anni. Un elenco nel quale spicca Julia Casu Masia Porcu. La strega Julia Carta. A Siligo, sul finire del 1500, le faccende religiose sono appannaggio di un parroco che si chiama Baltassar Serra y Manca. Uomo di Chiesa e, al contempo, commissario dell’Inquisizione. Un giorno come tanti, mentre somministra le confessioni, il parroco viene a conoscenza di una diceria che lo mette sulla difensiva. Dall’altro lato dello scranno c’è una donna del paese, Barbara de Sogos. Una che si confessa e si comunica regolarmente, onesta donna di casa sul conto della quale non circola mezza voce in tutto il paese. Quando la de Sogos si alza e se ne va, dopo aver vuotato il suo pesante sacco, don Baltassar suda freddo. Dopo Barbara arrivano Jagomina Zidda e Jagomina Enna. E poi Joana Pinta, Joana Seque Malizia ed alcune altre. Negli sfoghi di tutte fa capolino quel nome. Julia Carta. Vicina di casa di molte. La stessa, soprattutto, che sembra andare dicendo in giro che i peccati, per veri o supposti che siano, non vanno necessariamente riportati in confessione. Non tutti quanti, almeno. E non sempre. C’è qualcosa che non va in quella donna. In quello che dice, che non è certo ortodosso. E nelle cose che fa, soprattutto. Perché, adesso, mezzo villaggio di colpo inizia a lamentarsi col parroco delle singolari pratiche di quella strana donna. Dicono che fabbrichi pungas, amuleti. Che possieda strane rezettas, ricette. Che pratichi suffumigi, cioè affumentos, ed utilizzi verbos, formule, che altro non sono che fortilesas, sortilegi, hechisos, incantesimi, e malefìci, perfino. Tutti operati da Julia. Siligo è poco più di un ammasso di stamberghe di pastori ed agricoltori, che si spaccano la schiena su di un terreno che Dio non ha voluto poi così fertile. La monotonia della vita - e perfino della morte - qui è scandita da un potere straniero che tiene il popolo alla catena. Ma nessuno ha più voglia di sollevare vespai. Soprattutto, sulle coscienze e sulle anime regna ancor più salda la Chiesa di Roma, per mano della spada del vicerè che, a sua volta, deriva il suo potere dai sovrani di Spagna. Le bugie hanno le gambe corte, è vero. Ma le dicerie procedono in fretta. E’ una bomba, che deflagra tra le mani di una donna umile, analfabeta, povera. Julia è figlia di un muratore. Moglie di un contadino. E madre di sette figli. Tutti morti eccetto uno, Juan Antonio, che le sarà di conforto negli anni di carcere. Ma negli angoli bui del paese, e di fronte ai foxili, i focolai che riscaldano le notti fredde e ricolme di stelle dell’interno, si sprecano i racconti di Julia indovina, di Julia guaritrice, di Julia detentrice di arti antiche. Proprio come sua nonna. Proprio come tante donne del vicinato, amiche dei gitani di passaggio e, perciò, introdotte alle loro dottrine misteriose ed ai servigi che queste garantiscono senza nemmeno necessitare di una remunerazione di sorta a chiunque tra la popolazione abbisogni di un supporto in più nella miserevole fatica che è, in quei tempi oscuri, sopravvivere. Julia Carta viene arrestata il 18 ottobre 1596 a Mores, in casa del padre, mentre le voci si fanno sempre più incontrollabili e sono sempre più le persone che la additano, di volta in volta e con sempre minore cautela, come coga, hechizera, magarcha, maghiaglia, o bruja, per dirla all’ispanica. “Brussa!” gli urlano alcuni, i più sfacciati, in strada. E’ la stessa espressione che sopravviverà ai secoli per indicare chi si è dato al malaffare, smarrendo sé stesso e la propria anima come solo una strega può fare. L’Inquisizione, già sistematasi nel forte sassarese, ha buon gioco nelle indagini. Ma Julia è giovane e testarda. Nega. Ritualmente, le vengono indirizzate tre moniciones. Inviti a liberare la coscienza dicendo la verità. L’avvocato fiscale Thomàs Pitigado, che assiste al processo, le contesta come da copione le accuse formali. Tutti sinonimi di un solo capo, che le verrà formalmente addebitato il 21 novembre. Stregoneria. Avrebbe perfino provocato la morte di una donna di Siligo, Maria Virde. Così, tra l’autunno 1596 e l’anno successivo, compare in tre differenti occasioni davanti agli inquisitori. Ma rimane restìa. E de Arguello, l’inquisitore incaricato di saggiare la sua colpevolezza, si gioca l’ultima carta. Minaccia di tortura ed avviamento alla càmara del tormento. Julia viene legata, e mentre i suoi aguzzini le mostrano con perizia il braccio meno clemente della Chiesa, snocciolando di fronte ai suoi occhi esterrefatti i tanti strumenti che il Santo Ufficio ha saputo creare per mondare i corpi e le menti, la sua anima scricchiola. E’ un attimo, e la fortezza del suo intimo cede. Provata dalla gravidanza e dal mal di pietra che le dilania le viscere, non resiste più di tanto. Gettata nelle latebre delle prigioni del Santo Ufficio, presto confessa. E’ vero, pratica le arti della madre terra. Lo fa in ossequio al lascito ancestrale della sua famiglia, che da epoche immemori dialoga con le stelle, ed addirittura con il demonio. La bestia l’ha tentata senza sosta, piegandola a rapporti di vario genere, anche sessuali, in quella zona d’ombra che separa il sonno vero e proprio dalla veglia semicosciente. Tutto mentre Costantino Nuvole, il suo sposo, le dormiva placidamente accanto. Ammette tutto. Nuovi incantesimi realizzati, altri rapporti con il demonio consumati perfino tra le mura del fortilizio. De Arguello vorrebbe per lei una pena esemplare. Più del castigo sinora inflittole da una Chiesa di santo ha ben poco. Julia è colpevole. E’ una strega di quelle autentiche. Non considera nemmeno come fondante il valore della confessione. E allora, è peggio che strega, è strega e luterana. Due termini che, nella Sassari figlia della Controriforma, che si batte con le unghie e con i denti contro la piaga del luteranesimo e dei riformati attivi in Corsica e Provenza, diventano un unicum, ed un’icona del male assoluto. Tutto sembrerebbe condurla in fretta alle fascine del santo rogo. Ma il giudizio nella sua terra è più lieve che altrove. Il prezzo delle sue malefatte sono tre anni di carcere. E l’ammonizione formale una tantum a non ricadere nella colpa. Un avviso che, tuttavia, non la salva dal secondo processo, intentatole tra il 1604 ed il 1606. Ancora una volta, finisce davanti agli inquisitori. Ancora una volta, si salva. Perché le supposte arti oscure patrocinate da quella quarantenne, madre di una prole defunta e giunta in carcere recando in braccio un unico bambino abbigliato di stracci, sembrano essere appannaggio di tante altre donne del villaggio. Giovani, mature, anziane. Non si può processare un paese intero. Anche se è il villaggio stesso che lo reclama. Così muore anche il principio caro ai famigli di cui l’Inquisizione avidamente si nutre, la delatio. Proprio mentre lo stesso sacro tribunale di Spagna, soverchiato dalla fama nera che si è costruito intorno in secoli di sopruso, vede la sua autorità perdere di mordente e di utilità, fino a decadere temporaneamente. Dopo il 1614, di Julia Carta si perdono semplicemente le tracce. Sicuramente esce di scena, e guadagna la pace che attendeva da troppo. Forse, si tratta della pace eterna. Di lei, donna umile di un più umile villaggio sperduto tra le colline dell’interno della Sardegna di fine ‘500, non resta molto. Nessuna rappresentazione. Soltanto cronaca giudiziaria, resoconti infamanti. Ed un segno incerto, tracciato con mano tremante alla fine di un foglio ormai ingiallito e consunto dai secoli. La sigla all’abiura ufficiale che i suoi detrattori hanno voluto attribuirle a fine-calvario, e che suona così: “Eo Julia Carta, naturale e habitadora de sa villa de Siligo, que ynogue
so presente dainantis de sa Señoria sua, comente Inquisidore qui sunu,
contra sa heretica pravedade et apostasia in custu regnu de Sardiñya et
su districtu sou po auctoridade appostolica et ordinaria. Postu de inantis
meu custu sinnu de sa rugue et sos sacrossanctos Evangelios qui cun sas
manos mias corporalmente toco, reconosquende sa verdadera catholica e
appostolica fide, abjuro, detesto et maleygo tota ispecie de heregia qui
si pesat contra sa sancta fide catolica et lege evangelica de nostru
Redemptore et Salvadore Jhesu Christu et contra sa Sancta Sede Appostolica
et Ecclesia Romana, specialmente a ycudda qui eo, comente et mala, so ruta
et tengo confessado daenantis sa Señoria Sua, qui ynogue publicamente si
mi est lehido, et de su qui so ystada acusada, et juro et promitto de
tenner et bardare semper cudda sancta fide qui tenet, bardat et insiñat
sa Sancta Mater Ecclesia, et qui semper appo como esser obediente a Nostru
Señore su Paba e a sos sucessores suos qui canonicamente suseden in sa
Sancta Sede Appostolica, et a sas determinaçiones suas; et confesso qui
totus cuddos qui contra sa sancta fide catholica han como venner son
dignos de condenaçione, et promitto qui may mi appo acompañare cun
cuddos et qui cantu in me hat como esser los appo a perseguire et sas
heregias qui de cuddos appo como isquire, los appo a revellare et
notificarelu a quale si quergiat Inquisidore dessa heretica pravedade et
perladu de sa sancta Mater Ecclesia in hue hat qui mi acate, et juro et
promitto qui appo a rezier humilmente et cum paçiençia sa penitençia
qui mi est istada o hat como esser posta cun totus sas forzas e pudere meu
et la deppo cumplire in totu et per totu senza andare nen venner contra a
issa nen contra cosa nexuna nen parte de issa , et quergio et consento et
mi piaguet que, si algunu tempus, su qui Deus no quergiat, esseret o hat
como venner contra sas cosas subra naradas o contra quale si quergiat cosa
o parte de issas siat appida e tenta po impenitente relapsa, et mi somitto
assa correptione, in veridade de sos sacros canones, pro qui in me,
comente et persona culpada dessu dictu delictu de heregia, sian executadas
sas çensuras et penas in cuddas postas, et dae como pro tando et tando
pro como consento qui cuddas mi sian dadas et executadas et las appo a
suferrer cando si siat si alguna cosa si mi prohare de haver rupidu de su
subra naradu pro me abjuradu; et pregu assu presente notariu qui mi lu
diat pro fide et a sos presentes qui siant de custu testimonjos.” [T.Pinna,
Storia di una strega.
L’Inquisizione in Sardegna. Il processo di Julia Carta, Sassari, Edes, 2000.] |
Sezioni correlate in questo sito:
- Storia e dintorni
- "Stregoneria, eresia e Santa Inquisizione" (mostra permanente presso il Palazzo Episcopale di Castelsardo, SS)
www.duepassinelmistero.com Avvertenze/Disclaimer
Maggio 2012