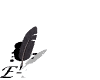TEMATICHE:
Due passi nell'Italia nascosta
Simbologia e Cultura Orientale
UTILITY:
Ricerca veloce titoli per argomento
SERVIZI:
|
Sulle orme di Alarico |
||
|
di Simone Petrelli |
||
|
Excidium. Exterminium. Saevitia. Ripiegata sui suoi morti per fame, per peste, per ferro nemico, Roma non assomiglia che allo spettro di sé stessa. Brucia inerte, gemendo le sue oscure maledizioni tra le fiamme appiccate dalle schiere di colui che l’ha presa dopo ottocento anni di inviolata pace armata. Il colpevole è un uomo nel pieno vigore dei suoi quarant’anni. Nato in un villaggio dell’area danubiana che oggi appartiene al territorio rumeno. Nelle sue vene scorre il sangue dei Balti, una tribù di girovaghi e conquistatori di stirpe celtica che hanno consumato le strade d’Europa colonizzando contrade dai fiordi scandinavi fino all’immenso granaio d’Ucraina. Alarico, si chiama. Il violatore del sacro suolo. Alarico, il distruttore dell’ultima memoria imperiale. Alarico, il re di tutti i Goti.
Alarico (fonte: wikipedia.org) La notte del 25 agosto 410 porta con sé per i romani ben altro che la consueta malarica calura. Con le tenebre si abbatte sull’Urbe il peggiore degli incubi. Quello destinato a soppiantare definitivamente un’èra ed un sogno di civilizzazione universale, soverchiati entrambi dalla pressione inaudita che le cento e più razze di barbari migranti esercitano sui confini di Roma. Il prestigio di capitale dell’Impero, quello sì è riuscito ad allontanarsi indenne dall’Urbe per prendere più consona dimora in quel di Ravenna, mentre Bisanzio la sofisticata invoca a gran voce la primazia tra le città del mondo conosciuto. Solo la voce di Roma in questo clamore non si ode più. E’ caduta, l’Urbe dei padri, tradita dagli ultimi del suo stesso popolo, che nottetempo sono riusciti nell’impresa folle di sabotare gli accessi concedendo il fianco della città ai Goti. Così, le avanguardie armate di Alarico hanno potuto fare irruzione a Roma a notte fonda, e passando per giunta proprio dalla porta principale. La Porta Salaria deputata a raccordare la parte nuova dell’omonima arteria nata per il trasporto del sale con quella di più antica memoria, che esce dalla città e, attraverso la Sabina volge all’Adriatico. Facendosi largo tra le strade addormentate, i Westgoten hanno ridotto al silenzio perpetuo gli esigui manipoli a difesa delle mura. Hanno atteso l’arrivo dell’orda, ed è cominciato l’inferno in terra. Un sacco da settantadue ore filate di morte e scompiglio. Anche se il re si è violentemente raccomandato, le schiere ansiose dei suoi sgherri danno il peggio di sé un po’ ovunque. Nel marasma, Papa Innocenzo I si è assicurato requie ponendosi repentinamente sotto la protezione ufficiale del primo vero monarca che i Goti hanno deciso di darsi nel corso della loro turbolenta storia. Così facendo, ha esteso la protezione di Alarico e della sua spada implacabile sulle chiese maggiori e perfino sul tesoro degli Apostoli. Quest’ultimo è stato portato in tutta fretta in Vaticano, al sicuro, con una processione frettolosa accompagnata da un flebile canto dei Salmi del tutto incapace di zittire l’eco del macello scatenatosi per le vie dell’Urbe. Alarico ed i suoi guadagneranno la via d’uscita non prima del 28 agosto. Ma quella che si lasceranno dietro sarà una Roma assolutamente diversa, e certamente trasfigurata in peggio. Una Roma, soprattutto, immensamente più povera, considerato che l’orda intenta a muovere sulle campagne tra le grida acute del volgo sconvolto ha avuto tutto il tempo ed il modo di metter mano alle ricchezze di cui la città trabocca. Sacco di Roma ad opera dei Visigoti, J. N. Sylvestre, 1890 (fonte: wikipedia.org).
I Visigoti che riprendono la via portano con sé gli ori ed i preziosi sottratti più di tre secoli prima in quel di Gerusalemme da Vespasiano in persona, soggiogatore dell’Oriente. Venticinque tonnellate d'oro e centocinquanta di argento, ammassate sui carri che arrancano in una carovana interminabile. Tanto bottino, dunque, ed altrettanti prigionieri, prelevati a sfregio dalla divelta aristocrazia romana rimasta a languire tra le macerie dei palazzi di un potere che si è volatilizzato all’istante. Alarico prende la via del sud, spinto da una smodata urgenza di raggiungere il sole d’Africa e, magari, dal profondo disagio di mettere più strada possibile tra sé e la città profanata. Ma ai barbari armati manca qualcosa di assai più prezioso dell’oro dei forzieri. Tanto seguito significa altrettante bocche da sfamare, e sulle schiere gote vincitrici già grava una preoccupante penuria di viveri. Ma l’agro romano è un granaio immenso, che si presta ai più sfrenati sogni di razzia. Saziata la fame, si procede verso sud. Sempre più in fondo alla penisola, fin dove la terra cede il passo al mare. I Goti espugnano la Campania Felix, marciando sulle rovine di Capua prima e Nola poi. Col sole si combatte, col buio si festeggia. E sono orge senza memoria e senza futuro. Con pietanze infinite servite da sguatteri cenciosi che solo qualche giorno prima erano i figli partoriti dalla migliore nobiltà dell’Urbe, e fiumi di Falerno consumati in gozzoviglie pantagrueliche. Barbarico pròdromo della parentesi lucana ed introduzione, soprattutto, alla fase finale del piano del re. Raggiungere Brindisi. Razziare navi. Fare rotta sulla Libia. I Goti si tuffano sull’Apulia, forzano le difese di Brindisi e salgono sulle imbarcazioni. Ma Roma ha lanciato il suo ultimo incantesimo, e le barche stracolme di armati vengono scosse con foga da un fortunale che colpisce duramente gli equipaggi improvvisati e li costringe a fare nuovamente vela sulla terraferma. Per quella via non si passa. Ma Alarico non si arrende. L’inverno si approssima, ma riprende il comando dell’orda ed ordina la marcia forzata verso il Bruzio. Tenteranno la via della Trinacria, e di lì guadagneranno la mèta. La barbara calata è inesorabile, e presto lambisce la rocca che, a Reggio, delimita l’accesso al canale di Sicilia. La lotta con la guarnigione locale è feroce e senza requie. La città viene data alle fiamme. L’incendio è tanto esteso e selvaggio che le lingue di fuoco si scorgono perfino da Messina. Si diffonde il panico, ed è un terrore cieco quello dei dardi nemici, dei palazzi e dei campi devastati che si intravedono ad appena un braccio di mare di distanza. Giunti di fronte al mare ed alle masse di disperati che cercano riparo in terra di Sicilia, Alarico si arresta. Non si è ancora placato, ma un’ombra inquina la vampa che gli si leggeva negli occhi. Non raggiungerà mai la costa africana, nodo strategico del Mediterraneo e terra più produttiva dell'Impero. Ha da poco passato i quarant’anni, ma sembra svuotato del suo vigore indomito. Appare pallido e gonfio. Colpa, forse, della lunga marcia, della calata infinita lungo lo stivale. Della malaria endemica che attanaglia il Bruzio, certamente. Ed ancor di più dei protratti stravizi. La sua orda non può mantenere la posizione in eterno. Così ripiega su Cosenza. Alarico cade, stroncato da un male oscuro o, più verosimilmente, da un colpo di lancia fatale, ricevuto durante l’assedio reggino. I Visigoti, rimasti senza guida, piangono la dipartita del loro primo, vero re. Homo indomitus capace di piegare il corso della storia estraendo da un popolo di girovaghi dozzinali e militarmente disorganizzati l’essenza di un esercito di conquistatori. Ai suoi fedelissimi non resta che approntare la regale sepoltura, consegnando la cronaca del sovrano nato in terra rumena nelle mani della leggenda diafana del flagellatore delle terre romane. Scompare così l’Alarico storico, per far posto al mito di un condottiero caduto non si capisce esattamente come e, soprattutto, misteriosamente sepolto non si sa dove. E’ un racconto antico, questo, che si lega per di più a doppio filo con quello dell’imperscrutabile destino di un favoloso tesoro, strappato all’abbraccio dei forzieri di Roma per essere ammassato sui carri dei barbari nella rocambolesca e furiosa marcia a metà tra l’avanzata e la fuga che drammaticamente è giunta al termine tra le nere selve della Sila. Un racconto antico, dicevamo, in merito al quale Auguste De Rivarol aveva torto. Come ogni antico avventuriero, come ogni gentiluomo di fortuna che si rispetti, forse nello stilare le sue memorie si era abbandonato un po’ troppo all’improvvisazione. Così, aveva finito per inquinare la ricostruzione di quel romanzo rocambolesco che era stato la sua vita con l’amara ma potente malia dell’inverosimiglianza, della diceria, della leggenda surreale perfino. Il primo decennio dell’Ottocento vede un’altra marcia insinuarsi lungo lo stivale. E’ quella dei napoleonici alle dipendenze del generale Manhès, con il De Rivarol ufficiale di brigata e, soprattutto, autore del primo reportage ante litteram sulla Calabria del primo Ottocento. Forse, tra il 1809 ed il 1812 il nostro napoleonico cronista aveva sostato davvero lungo il fiume Crati, riportandone poi minuziose descrizioni tra le pagine del suo manoscritto. Di sicuro, tuttavia, non si era mai imbattuto nei due scudi di foggia antichissima saldati insieme. E nemmeno nel loro spaventoso contenuto. I resti mortali di un re di tutti i Goti e storico saccheggiatore di Roma seppellito in tempi remotissimi in quelle contrade. Alarico. De Rivarol si sbaglia, ma forse il suo è un abbaglio inevitabile, perché nel 1810 Das Grab im Busento è poco più di un pensiero nella mente del conte August von Platen. August von Platen-Hallermünde ritratto da Johann Moritz Rugendas , 1830 (fonte: wikipedia.org) Dovranno passare altri dieci anni perché il drammaturgo tedesco condensi le infinite leggende cosentine in una ballata, La tomba nel Busento, destinata a riscuotere un successo maiuscolo in tutta Europa. Una fama repentina che farà presto in modo che perfino Giosuè Carducci ne curi una traduzione italiana. Il testo suona così: Cupi a notte canti suonano Da Cosenza su ’l Busento, Cupo il fiume gli rimormora Dal suo gorgo sonnolento. Su e giù pe ’l fiume passano E ripassano ombre lente: Alarico i Goti piangono, Il gran morto di lor gente. Ahi sì presto e da la patria Così lungi avrà il riposo, Mentre ancor bionda per gli omeri Va la chioma al poderoso! Del Busento ecco si schierano Su le sponde i Goti a pruova, E dal corso usato il piegano Dischiudendo una via nuova. Dove l’onde pria muggivano, Cavan, cavano la terra; E profondo il corpo calano, A cavallo, armato in guerra. Lui di terra anche ricoprono E gli arnesi d’òr lucenti: De l’eroe crescan su l’umida Fossa l’erbe de i torrenti! Poi, ridotto a i noti tramiti, Il Busento lasciò l’onde Per l’antico letto valide Spumeggiar tra le due sponde. Cantò allora un coro d’uomini: "Dormi, o re, ne la tua
gloria! Man romana mai non víoli La tua tomba e la memoria!" Cantò, e lungo il canto udivasi Per le schiere gote errare: Recal tu, Busento rapido, Recal tu da mare a mare.
Il corso del Busento presso Cosenza in una stampa ottocentesca (fonte: indire.it)
Quest’ultimo provvidenzialmente deviato nel suo corso, onde consentire alle schiere gote di approntare con relativa facilità un’inviolabile sepoltura al più grande dei loro condottieri. Per questo, terminato lo scavo, la sorte di Alarico sarebbe stata seguita anche dalla totalità degli schiavi impiegati allo scopo, eliminati repentinamente per evitare di lasciare in vita scomodi testimoni. L’immagine che emerge dai versi di von Platen, per quanto singolare e pittoresca possa apparire, trova conferma anche in quanto riportato nelle cronache più antiche, vale a dire quanto a proposito riportato sia dallo storiografo bizantino di origine alana Giordane che dal romano Flavius Magnus Aurelius, consigliere di Teodorico e più noto come Cassiodoro di Squillace. Eppure, riflettendo sul destino delle spoglie de re goto e dei suoi tesori, nel corso dei secoli l’immaginario non solo locale ha saputo partorire e consolidare un coacervo sorprendente di versioni ed ipotesi. Un coacervo nel novero del quale, anche spuntando la voce relativa al fantasioso episodio riportato dal De Rivarol, la lista dei papabili luoghi di riposo eterno dell’antico e temuto sovrano barbaro non accenna comunque a ridursi di molto. Allo stesso tempo, non sembra destinata a restringersi la schiera dei tanti volenterosi che, nel corso dei secoli, si sono cimentati nella favolosa impresa di scovare le ultime tracce mortali di quel barbaro condottiero che, secoli addietro, aveva reclamato di fronte ad un potere al tracollo il suo diritto di essere Magister Militum. Nella prima metà del Settecento, un preside della Calabria Citeriore e patrizio napoletano che nel suo carnet poteva vantare i titoli di dottore in legge, avvocato concistoriale, cappellano del tesoro di San Gennaro e, soprattutto, monsignore - il tutto racchiuso nella persona di Giuseppe Capecelatro - finanziò una serie di ricerche nelle campagne del cosentino. I mille scavatori radunati dal patrizio setacciarono con particolare insistenza la confluenza di due fiumi, il già menzionato Crati ed il Busento, che orlano di esigui flutti buona parte dei confini dell’abitato di Cosenza. Nonostante le premesse incoraggianti e la considerevole energia profusa, l’ardita impresa del religioso e dei suoi mille scavatori non incontrò tuttavia il successo sperato. Identico, scoraggiante risultato registrato, poco dopo l’unità d’Italia, dall’analoga iniziativa patrocinata da un deputato della sinistra locale, Davide Andreotti. E’ il 1937 quando la ricerca, esauriti i toni più canonici, inizia ad ammantarsi di paranormale. Fausto Terzani è un volenteroso – sebbene non ufficialmente titolato - archeologo nativo di Ascoli Piceno quando decide di cimentarsi nell’impresa di scovare la favolosa tomba di Alarico. Porta con sé una collaboratrice francese di nome Amelie Crevelìn. La donna, oltre che nota sensitiva, è particolarmente versata nella liminale arte della rabdomanzia. Così, i due iniziano a rastrellare, bacchette alla mano, i suburbi di Cosenza. Paradossalmente, malgrado gli scarsi risultati prodotti, la loro ricerca è tanto singolare da presentare l’indiscusso merito di far parlare prepotentemente di sé. Così, la notizia della strana coppia intenta a setacciare le viscere del suolo calabrese finisce per valicare i confini dell’Italia fascistissima, facendosi largo fino a Berlino. Dove viene captata da un uomo che ha un udito finissimo in tema di suggestioni occulte. Quell’uomo è un occhialuto bavarese che ostenta per i corridoi del Reichstag la sua impeccabile divisa nera di Reichsführer delle Schutzstaffel. E’ comandante della polizia e delle RSHA, le Reichssicherheitshauptamt forze di sicurezza, ma soprattutto fondatore della Ahnenerbe Forschungs und Lehrgermeinschaft. L’Associazione per la ricerca e la diffusione dell'eredità ancestrale votata alle ricerche riguardanti la storia antropologica e culturale della razza germanica, i cui membri, per metà soldati e per metà scienziati, presentano sulla divisa una runa Odal incrociata ad una spada. Le SS-Ahnenerbe dimostrano particolare interesse in relazione al mito della morte e della sepoltura del condottiero visigoto, e Himmler stesso approfitta di una visita ufficiale del Fuhrer a Roma per accompagnarlo in Italia e ritagliare qualche settimana per sé ed i suoi a Cosenza. Cercano di rintracciare la tomba nascosta del re barbaro alla confluenza del Busento e del Crati non solo per ridare ufficiale lustro ai destini un sovrano germanico che la storia volle più grande di Roma, ma anche e soprattutto per mettere le mani sul tesoro che le leggende vorrebbero sepolto insieme ad Alarico nel ventre della terra cosentina. E soprattutto perché, se i preziosi trafugati a Roma sono gli stessi dirottati sull’Urbe dopo la conquista di Gerusalemme, un certo intuito suggerisce al gerarca che sotto metri di terra scura potrebbe celarsi addirittura l’Arca dell’Allenza di biblica memoria. Ma i neri accoliti di Himmler non trovano nulla, e dopo aver rovinato la festa al piceno archeologo dilettante ed alla medium francese sua sodale volgono la loro attenzione altrove. Alcune cronache sostengono che il capannello di SS non si sia allontanato poi troppo. Pochi giorni dopo vengono infatti visti scavare intorno ai sepolcri delle famiglie Masci e Baffa Trasci nella Chiesa medievale di Santa Sofia d’Epiro, altro villaggio in terra consentina che ha tuttavia la caratteristica peculiare di essere popolato da una maggioranza arbëreshë, albanese, conservando costumi tradizionali slavi e riti bizantino-greci. Negli anni Cinquanta, il mito di Alarico viene rispolverato dal dimenticatoio in cui le bombe e l’oblio della guerra lo avevano precipitato. C’è chi investe nuovamente sulla pista paranormale, convinto che per ritrovare un dato perduto nella storia ancestrale dell’Europa si necessiti di un supporto che va ben oltre le più professionali abilità scientifiche. E’ il 1951 quando due pugliesi autodefinitisi sensitivi sottopongono il cosentino al misterioso vaglio del loro potente pendolino. I due si chiamano Adolfo Greco e Giuseppe Belfiore. Il secondo è il più motivato ad intraprendere la ricerca, perché sostiene di essere stato visitato in sogno da Alarico stesso, il quale oltre ad esortarlo all’impresa gli avrebbe suggerito di scavare in prossimità di una frazione del comune di Carolei, a Vadue, località che presenta i ruderi di un Ninfeo Romano. Proprio durante un sopralluogo, il pendolino di Greco e Belfiore segnala qualcosa ad una profondità di circa 50metri… Ma sobbarcarsi degli scavi veri e propri rappresenta per i due sensitivi un’ipotesi assolutamente impraticabile, massimamente per i costi esorbitanti ben al di là della loro portata. I due decidono allora di giocarsi l’asso nella manica. Ed inviano un accorato appello a qualcuno che sta molto in alto. Che ha molti fondi. E che nutre una passione non indifferente per l’archeologia. Il re Gustavo Adolfo di Svezia. Che tuttavia, presagendo anche l’esborso notevole di asportare tonnellate di terra per raggiungere il misterioso bersaglio posto a decine di metri di profondità, evita di dare riscontro alla coppia di volenterosi. Più passa il tempo, più gli elementi di questa antica equazione finiscono per essere messi in dubbio uno dopo l’altro. Così, si iniziano a vagliare ipotesi collaterali. C’è chi, fedele ad un’ipotesi meno ortodossa e ben più creativa di quella cosentina, sposta ricerca, squadre e scavi presso un corso d’acqua che con il Busento ha in comune la quasi totalità del nome e la confluenza nello Ionio, il rio lucano Basento. C’è Erik Furugard, che di mestiere fa il ricercatore, che si prende la briga di riesaminare la gli scritti di Giordane finendo per appigliarsi ad un’indicazione che situerebbe il sepolcro pedes montis, cioè nelle vicinanze delle pendici di un rilievo. Così, al tedesco viene in mente che nella valle del Crati esiste, nei pressi del paese di Domanico, una cittadina chiamata Bisentio. In questo abitato che un tempo era indicato col toponimo di Bisignano sorge una località chiamata Grifone in cui svetta il Cozzo Rotondo. Probabilmente un tumulo funerario di forma circolare ellittica che ricorda in modo impressionante le tombe concepite dalle popolazioni del’est europeo – Daci e Goti compresi. Oggi questa strana collinetta risulta visibile perfino dall'Autostrada del Sud, transitando nei pressi di Tarsia. Dal 1989 Natale e Francesco Bosco, che oltre alle comuni origini condividono una sana passione per la ricerca archeologica, hanno intrapreso la loro personalissima lotta alla damnatio memoriae di Alarico. Partendo dalla convinzione che deviare un fiume come il Busento rappresenti un’operazione che non poteva passare inosservata neanche nel 410 dopo Cristo. Indagando e perlustrando, i due hanno finito per scoprire un sito quantomeno interessante nei pressi della confluenza del fiume Caronte con il torrente Canalicchio. Risalendo il fiume, più a monte ci si imbatte nel ponte di Carolei, laddove un vecchio viadotto romano sul Caronte nasconde una vallata che negli anni è stata protagonista dei misteriosi racconti degli anziani del luogo. Alla limba di Alimena c'è un tesoro brigantesco, dicono i vecchi ammassati nelle piazze dei paesini limitrofi. E’ una vallata desertica, quella sotto l’Alimena, che in antichità ospitava una strada che, partendo da Cosenza, portava al mare, ad Amantea sul Tirreno, laddove i Goti diretti alla Trinacria sostarono prima di risalire la montagna per raggiungere Cosenza.
Veduta da una delle grotte dell’Alimena (fonte: alimena.com) Questo luogo denso di memorie è ricolmo di rocce costellate di incisioni iniziatiche che starebbero ad attestare la sacralità del luogo. La conferma giunge da un’enorme croce, venti metri di altezza per dodici di larghezza, scolpita sulla roccia presso un fianco della valle in una località denominata Rigardi. Toponimo che in lingua gotica indica “osservanza rispettosa”. Sull’altro lato, risalendo il ponte di Carolei per un chilometro e mezzo, una rupe a strapiombo del massiccio vede aprirsi alcune fenditure naturali. All’interno della più grande delle due grotte naturali a strapiombo sulla valle, è celato quello che assomiglia paurosamente ad un rozzo altare di fattura germanica. Altare, questo, che nonostante si trovi in una cavità calcarea di origine vulcanica poggia su di uno strato di sabbia di origine fluviale… Forse, i fratelli Bosco sono pericolosamente vicini alla soluzione dell’enigma. Ma dall’alto nessuno ha sinora rilasciato permessi per scavare nell’area. Non i funzionari della Soprintendenza archeologica di Reggio Calabria, che hanno negato qualsiasi validità alle ipotesi dei Bosco. Paventando un pericolo ulteriore e ben più inviso dell’oblio della memoria. Il rischio che scavi non ufficiali vengano condotti in loco da tombaroli di fortuna, alla ricerca di venticinque tonnellate d’oro e centocinquanta d’argento forse sepolte assieme a misterioso Alarico.
Il fiume Busento alla luce dell’alba appare poco più di un modesto rigagnolo, il cui colore sembra ricalcare quello degli ulivi piantati un po’ ovunque nelle vicinanze. Scorre veloce tra sabbia gialla e pietre, sprofondato nel suo letto largo ma non quanto il Crati, che è un sussurro flebile di acqua in movimento lanciato sul fondo di un alveo spropositato a causa delle frequenti inondazioni. Oltre il Crati si apre la Sila. Nobile montagna ammantata di foschie nel primo sole del mattino, che va a fugare il nero delle selve rampicanti restituendo respiro e luce alle gradinate ricavate dal lavoro dei contadini sulle colline ed ai pascoli che brulicano di greggi. Con un po’ di fortuna si riesce ad intravedere lo Ionio, un angolo di spiaggia che nel passato più remoto di questa terra ospitava gli artigiani navali della Magna Grecia. Sparite le torme di briganti, sfoltite drasticamente le fila di contadini e pastori, questo angolo di Calabria resta immerso in un silenzio crescente. Lo stesso deputato a mantenere intatto fino a chissà quando il segreto del sepolcro reale d’Alarico, primo ed ultimo re dei Visigoti che qui incontrò la morte, forse carico di un trofeo d’ori romani. (Autore:
Simone
Petrelli) |
Sezioni correlate in questo sito:
www.duepassinelmistero.com Avvertenze/Disclaimer
Giugno 2012